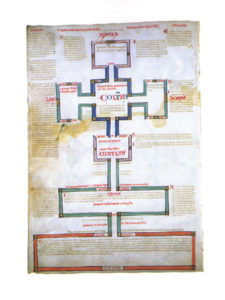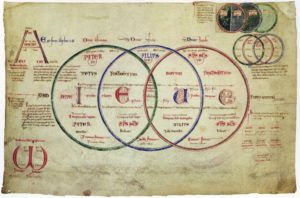QUANDO I SUMERI ABITAVANO ALLE FALDE D’ ‘A MUNTAGNA.
L’ABZU SUPERIORE
Premesso che l’aggettivo dio non è semanticamente penetrabile e che non è possibile sapere quando e da chi questo sia stato adottato per indicare qualcuno o qualcosa, ci sentiamo di dare
per probabile che colui il quale intese utilizzare per primo l’appellativo, intendesse manifestare che lo riferiva a qualcuno o qualcosa dotato di poteri infinitamente maggiori rispetto ai propri. Comunque sia, accadde con probabilità, che in un tempo non misurabile attraverso gli strumenti umani, un essere, stando a quanto viene raccontato nei testi sumerici, convenzionalmente definito dio, decise di stabilirsi nell’Abzu superiore, che i sumerologi concordemente identificano con il nord dell’Africa. Bisogna qui ricordare al lettore che la Sicilia fa parte della placca tettonica africana e che al tempo in cui i testi si riferiscono, cioè in epoca antidiluviana, con l’Africa era unita, in quanto in quel periodo il Mar Mediterraneo non era che una pozzanghera. Dunque, la divinità in questione aveva scelto come dimora l’Abzu superiore. Ora, i testi sumeri affermano che la divinità che loro indicavano con l’appellativo di Enki o Ea, ma che possedeva altri trentotto nomi, scelse di costruire la propria dimora nel luogo dell’Abzu superior, che ritenne più ameno e che da lui venne appellato, come si afferma nel testo intitolato dai sumerologi Il viaggio di Enki a Nippur, Eridu ovvero, secondo la nostra interpretazione, la terra promessa. Il toponimo risulta infatti formato dall’unione del lessema Er che significa Signore nella lingua germanica, affine alla sicana, o erde terra, ed eid che significa giuramento, promessa.
ERIDU, LA TERRA PROMESSA.
Dal significato del toponimo, dunque, si evince che le aspettative del dio rispetto a quel luogo assai ameno, in cui la biodiversità e la ricchezza di acque dolci non avevano pari, erano grandi per i progetti che intendeva realizzare. Ed infatti, tra i progetti poi realizzati, vi era quello di creare l’uomo. Nel poema in cui si parla della creazione, intitolato dai sumerologi che lo hanno tradotto “Enki e Ninmah”, e del quale riportiamo qui sotto il link: https://youtu.be/BwwcSu7dmd4?si=ALc2N-I1r5YuHncC, viene affermata una cosa per noi che andiamo a caccia di indizi, molto importante, che ritorna utile alle nostre ricerche e cioè che a Eridu Enki aveva installato il proprio laboratorio, e che l’argilla occorrente per l’esperimento della creazione era stata prelevata dall’Abzu superiore.
La divinità, come riportano i testi, nell’Abzu superiore operava intervenendo su tutti gli ambiti e migliorandolo in tutti i suoi aspetti, tanto che nel testo sopra menzionato, Eridu viene definito dagli dèi che partecipano al convivio che si svolge a Nippur, in Mesopotamia, un luogo paradisiaco si, ma che nasconde arcane e temibili forze appellate dai Sumeri con l’intradotto termine di “me”.
Ora bisogna concentrare le ricerche sulla identificazione della città di Eridu, presso l’Abzu superiore, e a tal fine non può passare inosservato che nei testi sumerici viene spesso citata La Montagna, che tramite l’articolo determinativo denota una familiarità di questa presso i Sumeri. Si rifletta sulla anomalia dettata dal fatto che in Mesopotamia non vi sono montagne, essendo una grande pianura, dunque questa doveva trovarsi altrove, Il lettore che ci ha seguito fin qui nelle indagini, avrà ormai notato il collegamento che esiste tra La Montagna e l’Abzu superiore e tra questo e la Sicilia. Di ciò è stato abbondantemente detto nel saggio Sicania: il futuro scritto nel mito, gratuitamente fruibile sui siti miti3000.eu e Adranoantica.it, pertanto rimandiamo il lettore in quella sede per maggiori approfondimenti.
TUCIDIDE E I TESTI SUMERI.
Ora, per procedere nelle ricerche, è necessario fare un salto in avanti di molte migliaia di anni rispetto al tempo dell’insediamento della divinità sumera nell’Abzu superiore, soffermandoci brevemente su quanto viene riportato nel V sec. a.C. dallo storico greco Tucidide. Sebbene egli sia interessato a raccontare gli eventi che portarono alla famosa guerra fratricida tra i Greci a cui diede il titolo di Guerra del Peloponneso, piuttosto che soffermarsi nell’ indagine delle etnie che popolavano la Sicilia al suo tempo e prima ancora, risulta comunque utile al fine della nostra indagine proporre al lettore quanto egli sbrigativamente afferma, in quanto col suo racconto lo storico indirettamente contraddice quanto sostenuto da
Diodoro Siculo tre secoli dopo, sebbene questi ben avrebbe dovuto conoscere le caratteristiche della Muntagna, che dal paese suo, Agira, è visibile allo stupefatto visitatore in tutta la sua gagliardezza e imponenza. Tucidide, nel libro IV della Guerra del Peloponneso, afferma che i Siculi, vinti i Sicani in guerra, ne abitarono le parti migliori, quelle della Sicilia orientale. Diodoro afferma, invece, che i Siculi si insediarono nella parte orientale dell’isola che trovarono vuota, essendo stata abbandonata dai Sicani in seguito alle eruzioni del vulcano Etna, ‘A Muntagna per i Siciliani.
L’EQUIVOCO DIODOREO.
Poiché nella storia tramandata oralmente dai Sicani, storia che Diodoro ben conosceva, non si era mai fatto accenno a guerre condotte tra il sedicente popolo dei Siculi e quello autoctono dei Sicani, Diodoro, che era Siciliano, per giustificare la presenza dei Siculi nella parte orientale della Sicilia, ipotizzò una occupazione del territorio da parte dei Siculi in seguito ad una presunta fuga dei Sicani, dovuta, a suo dire, alle devastanti eruzioni dell’Etna. Tralasciando il fatto che per quanto spettacolari e temibili le eruzioni del vulcano potessero essere state, non potevano comunque essere così devastanti da indurre un intero popolo ad abbandonare un territorio ampio come è quello della Sicilia orientale – si tenga conto che
l’eruzione più distruttiva mai registrata a memoria d’uomo, quella del 1669, aveva un campo lavico esteso 40 km e non avanzò oltre i 17 km, sebbene sia riuscita a lambire la città di Catania- a rendere poco credibile il racconto di Diodoro, è la constatazione che dopo un’eruzione vulcanica, prima che la lava si trasformi in fertile humus occorre che trascorrano secoli se non millenni. Comunque sia la inverosimile tesi di Diodoro divenne tuttavia la più accreditata.
A questo punto della ricostruzione storica di quel lontano periodo, prima di proseguire, affinché il lettore possa meglio comprendere i passaggi che ci condurranno alla tesi che stiamo per esporre, è necessario che egli legga l’articolo: “Etna, ‘A Muntagna dei Sumeri”, pubblicato poco tempo fa in questo stesso luogo, in cui si ipotizza che la formazione della Valle del Bove possa essere dovuta ad una guerra nucleare combattuta in illo tempore tra fazioni in contrasto di una civiltà tecnologicamente avanzata, che abitava la Terra, e di cui rimane traccia nei racconti di molti popoli. Uno dei testi, il cui antichissimo contenuto non desta stupore agli eredi del popolo che lo ha redatto, quello indiano, è il testo che ha titolo i Veda. In
questo testo vengono descritte guerre combattute migliaia di anni fa con l’ausilio di armi tecnologicamente avanzate, come il bramastra o raggio infuocato (laser?) utilizzato soltanto dal dio Krsna. Se si accetta l’ipotesi supportata dalle numerose prove che derivano dai reperti archeologici giunti fino a noi, che nel passato cioè siano esistite sul nostro pianeta civiltà evolute tecnologicamente, si può allora immaginare che lo storico siciliano abbia potuto fondere due tradizioni in una. Infatti, egli, rendendosi conto che i suoi lettori mai avrebbero potuto accogliere come veritiero il racconto di una catastrofe indotta da armi tecnologiche capaci di spazzare via una montagna e ripiegando su una versione più credibile, attribuì a una catastrofe naturale, provocata dalle eruzioni dell’Etna, l’abbandono del territorio da parte degli abitanti sicani. Diodoro afferma però il vero quando sostiene che furono i Siculi a ripopolare successivamente il luogo, a patto che all’aggettivo siculo si dia il suo vero significato etimologico, cioè quello di mandriano. Infatti l’aggettivo siculo, utilizzando il metodo interpretativo da noi messo in atto e che trova nella lingua protogermanica il riferimento di comparazione per tradurre la lingua sicana, risulta formato dall’unione dei lessemi sich e Ku, dove col pronome riflessivo sich, sé, se stesso, si suole intendere un rapporto quasi consustanziale tra la vacca (Ku) e il mandriano. Ma tornando alla nostra ipotesi di lavoro, risulta plausibile supporre che per un tempo, – come accadde per Moenjo Daro, Sodoma, Gomorra e altre località coinvolte nella guerra atomica globale – non sappiamo quanto a lungo l’area etnea, in seguito al cataclisma nucleare, sia rimasta disabitata. L’assenza di antropizzazione e il cessato effetto delle radiazioni, favorirono la crescita di una vegetazione rigogliosa. Le mucche, che nel periodo della transumanza si erano spinte fin là, attratte dalla tenera erba che ormai vi cresceva, avevano fornito ai siculi, cioè ai mandriani, la certezza che il luogo era tornato ad essere abitabile. L’esempio di un caso moderno comparabile a quello qui supposto, ci viene fornito dalla bomba atomica sperimentale fatta esplodere dagli Americani sull’atollo di Bikini dopo aver allontanato i suoi abitanti. Questi vi fecero ritorno soltanto dopo trent’anni, avendo appurato che vi era cresciuta l’erba.
RAMESSES E I SICULI.
Quanto affermato su Diodoro a proposito dell’errore in cui egli sarebbe incorso, si potrebbe applicare anche agli Egiziani circa la battaglia che vede Ramesses II respingere i Popoli del Mare di cui facevano parte i Siculi. Il faraone, del resto, è stato colto in flagrante dagli archeologi che hanno trovato la stele ittita in cui si racconta la battaglia conclusa inpareggio, mentre il faraone si era addossata la vittoria – mai avvenuta – nella famosa battaglia di Cadesh. La coalizione dei Popoli del Mare, citati dagli Egiziani, riconducono, invece,alle coalizioni che si formarono tra le due fazioni in guerra presso ‘A Muntagna e di cui viene fatto l’ elenco nel poema intitolato Ninurta il prode.
INDIZI DI UNA GUERRA GLOBALE COMBATTUTA PRESSO L’ETNA.
Un titolo del genere potrebbe fare desistere il lettore dal continuare la lettura, ritenendolo eccessivo, ma faccia egli lo sforzo di giungere fino alla fine, seguendo l’enunciato nietzschiano che anche un pazzo talvolta dice la verità – e in termini di follia sappiamo che egli diventò maestro-. Per comprendere tale studio è dunque necessario analizzare attentamente i particolari del racconto sumerico, di cui riportiamo il link che l’ottimo youtuber mette a disposizione di coloro che sono animati di buona volontà e che va sotto il nome di “Ninurta il Prode e le pietre di Lugal E”: https://youtu.be/s6JHYwUpRd0?si=V2AhM9NmSm7WMxVH. Nel succitato racconto il protagonista assoluto è La Montagna, quasi personificata, come appare dal racconto e dall’articolo determinativo utilizzato per indicarla. L’allusione all’Etna, nome non ancora coniato nel periodo in cui fu steso il racconto, appare evidente. La Montagna, viene nominata con l’ausilio dell’articolo determinativo a testimonianza che essa era l’unica a possedere inequivocabili ed esclusive caratteristiche tali da non potere perciò essere confusa con altre. Che la montagna in questione possa essere identificata con il vulcano Etna, si evince da un passo del racconto che di seguito esporremo brevemente. Ninurta, il vincitore che si vanta di aver “spaccato” la Montagna, paragona questa ad un Cedro (albero che oggi cresce per lo più nell’area libanese) con le radici ben piantate nell’Abzu. Ricorderà il lettore che questo è il nome che i Sumeri avevano dato all’Africa, o sarebbe meglio dire alla placca tettonica africana della quale fa parte la Sicilia (al tempo in cui venne redatto il poema La Sicilia era attaccata all’Africa e veniva indicata come Abzu superiore). La conferma della identificazione della Montagna con l’Etna si trova in un altro passo dello stesso poema, in cui si afferma che Ninurta, rivolgendosi allegoricamente alla “lava e al basalto”, cioè ad uno dei popoli della coalizione che lo aveva combattuto, gli somministra la pena da scontare. Il riferimento alla lava e al basalto non può non essere attribuito a coloro che si erano posti dalla parte di Anzu, il ribelle che della caverne della “inaccessibile” Montagna
aveva fatto il suo quartier generale. Il poema, nell’allegorico catalogo dei popoli che si erano schierati a favore dell’una e dell’altra parte e che Ninurta paragona alle pietre con le loro diverse caratteristiche, indicherebbe la Sicilia come “la contrada ribelle”, sebbene nella guerra in corso tutti i popoli abitanti della Sicilia fossero schierati a macchia di leopardo. Che la catastrofica guerra citata nel testo sumerico sia stata combattuta presso l’Etna e che anzi in questo vulcano sia stato realizzato una sorta di hangar con annessa la sala di comando, di cui con tradimento si era impossessato Anzu, si deduce anche dal poema intitolato Ninurta il Prode, di cui riportiamo il link: https://youtu.be/wGIRhg7j-HU?si=EAKH8Q-2YnXLtT93
Nel contenuto del poema, nonostante l’apparente vaghezza della descrizione dei luoghi, si evince che la Montagna in cui Anzu è acquartierato, si trova nell’Abzu superiore, poiché Ninurta, indicato da Enki a motivo del suo valore nell’arte militare per assumere il comando dell’operazione, viene dotato dei poteri che Enki custodisce a Eridu, cioè nella sua reggia laboratorio dell’Abzu superiore.
CONCLUSIONE
Concludiamo il breve excursus ricordando al lettore che attraverso i miti sopravvive la storia di una civiltà e che, pertanto, nel mito greco sicano che vede i Ciclopi al? lavoro nei meandri del Vulcano e al comando di Efesto, per creare le armi – gli strali, ovvero i raggi infuocati (laser?) a Zeus per sconfiggere i Titani – si possa celare l’allegorico racconto vergato nella tavola sumerica qui preso in considerazione. A questa si aggiunga che poiché soltanto in Sicilia sopravvive una toponomastica che trova un riferimento ai testi citati e di cui si è detto spesso, qui ricordiamo soltanto il nome dei monti Erei, i quali potrebbero fare riferimento all’antica Eridu. Ma di questo verrà detto ampiamente nella prossima pubblicazione, dove verrà presa in considerazione la moltitudine di indizi presenti nei racconti sumerici che fanno riferimento a un gemellaggio avvenuto tra le città della Mesopotamia e quelle della Sicania
Ad maiora.
Francesco Branchina