
Le Etnee
Gelone di Siracusa: un rapporto privilegiato con Adrano.
No cari lettori, voi che non ci avete seguito fin dall’inizio delle nostre ricerche, sappiate: non abbiamo preso un abbaglio cronologico. Adrano subì, in diverse epoche, più di una rinominazione. Pertanto, facendo riferimento alla città di Etna nei fatti storici che si sono svolti durante il brevissimo regno di Gelone, documentati da Diodoro da Agira nella sua monumentale opera, Biblioteca Historica, è ad Adrano che ci si riferisce. Nel fornire in questa sede, una ricostruzione storica delle relazioni intercorse tra le città di Adrano/Etna e Siracusa durante il primo quarto del quinto secolo a.C., per brevità di spazio, non ritorneremo sulla questione della rinominazione rimandando quanti, tra i lettori, avvertissero il desiderio di approfondire tale argomento al saggio, Adrano dimora di Dei, nella storia del mediterraneo greco, e agli articoli apparsi su diversi siti web. Inoltre, per evitare di disorientare il lettore con il citare, di volta in volta, in tempi cronologici diversi, i differenti nomi con cui Adrano venne designata, e per non scambiarla a sua volta con Catania, anch’essa rinominata per un breve arco di tempo in Etna, nell’utilizzare il toponimo derivante dalla divinità eponima Adrano, metteremo tra parentesi il primevo nome di Etna.

Gelone diventa tiranno di Siracusa nel 489 a.C., cedendo al fratello Gerone il controllo su Gela che egli aveva assunto fin dal 491 a.C. Gela, Agrigento, Siracusa, erano in quel momento storico le città più potenti dell’isola. La potenza militare delle tre città veniva amplificata da una politica di mutuo soccorso dettata da vincoli parentali intercorsi tra i tre tiranni: Gelone aveva sposato la figlia di Terone tiranno di Agrigento, Damareta, e, come affermato, era fratello di Gerone a cui aveva ceduto la città di Gela. Tuttavia, numerose rimanevano le città stato sicule che potevano contare sul prestigio delle proprie armi, Adrano (Etna), la città tra le più antiche fondazioni sicane dell’isola, in cui sorgeva il tempio dell’ Avo primordiale, il più antico edificato nell’isola, era tra queste. Gelone, con l’apporto militare del suocero Terone e del fratello Gerone, conduceva brillantemente le operazioni militari contro i Punici che tentavano di erodere i territori delle nazioni presenti nell’isola: Sicani, Greci, Siculi (è questa una suddivisione territoriale schematica che accogliamo secondo la vulgata, ma che andrebbe riveduta nei rigidi confini territoriali ed etnici a loro attribuiti). Il momento che lo porterà a calcare da primo attore il palcoscenico della storia, gli sarà fornito dall’assedio a cui Imera sarà sottoposta da parte dei Punici. L’episodio sarà ricordato come, la battaglia di Imera, svoltasi nel 480 a.C. In questa occasione, nell’ottica di uno scontro tra civiltà, tra le città che erano venute in soccorso del greco, non poteva essere assente Adrano (Etna), la città che ospitava la divinità eponima, detentrice della tradizione ereditata dagli Avi. Diodoro afferma che i Greci erano fiaccati dallo scontro con i Punici e il loro morale era basso. Gli Adraniti (Etnei), sopraggiunti durante il corso degli scontri, infusero con il loro contributo tanto coraggio agli alleati da risultare decisivi per la vittoria sui Cartaginesi.
Adrano: Omphalos del culto primigenio.
Quale segno di riconoscimento al valore dimostrato, Gelone effettuò col bottino dei vinti una serie di elargizioni e riconoscimenti personali e collettivi a quanti avevano preso parte al conflitto come cittadini e alleati. Il re espresse in questa circostanza la volontà di erigere come ringraziamento, un tempio consacrato a Demetra, nella città sicula di Adrano (Etna) che si era particolarmente distinta durante i combattimenti. Diodoro nel rimarcare che mancava ad Adrano (Etna), – una terra tra le più feraci della zona etnea-, uno dei templi più importanti, dedicato alla dea dell’agricoltura e della fecondità, ci induce a supporre che l’aver assentito alla costruzione, nel territorio adranita, di un tempio dedicato ad una divinità greca, assumeva per entrambi: Siracusani da un lato, Adraniti dall’altro, i connotati di un consenso politico che un atto di devozione religiosa. Un atto questo, di grande significato simbolico che, per renderlo comprensibile ai nostri lettori, paragoniamo alla concessione che avrebbe potuto fare lo stato cristiano del Vaticano ai musulmani, concedendogli di costruire una moschea in piazza S. Pietro.
Gli ottimi rapporti che erano venuti a stabilirsi tra i Siculi e Gelone dopo la battaglia di Imera, fecero ben sperare il re tanto da ritenere che egli potesse dedicarsi ad una politica di unificazione dell’isola. Ma la unificazione politica presupponeva la creazione di una entità culturale e religiosa omogenea. Uomo di grande lungimiranza ed intelligenza politica, il re invitò alla sua corte i migliori poeti della Grecia. Ad essi affidò il compito di redigere delle composizioni letterarie volte ad ottenere un sincretismo culturale. Tra i letterati invitati a corte non poteva mancare Eschilo, espertissimo in questioni religiose; egli stesso iniziato ai misteri eleusini. Prevenendo quanti ci faranno notare che Eschilo giunse in Sicilia soltanto dopo la morte di Gelone avvenuta nel 488/7 a.C., chiamato da Gerone nella sua nuova reggia di Catania, noi opporremo la nostra ricostruzione dei fatti ricorrendo alle date, alle circostanze che determinarono le scelte politiche, alle doti politiche possedute dai personaggi attori degli eventi, e via dicendo.
Il sincretismo culturale elaborato da Eschilo nelle Etnee.
“ Che nome dunque i
mortali daranno loro?
Zeus ordina che siano
appellati sacri Palici.
E sarà il nome Palici come
se dato con giustezza?
certamente perché essi
vogliono tornare indietro<
dalle tenebre alla presente luce
Le Etnee, da una citazione di Macrobio nei Saturnalia V, 19,24.

È dibattuta la data in cui il tragediografo greco viene chiamato alla corte di Gerone a Catania (Dopo il 472 a.C. per Walter Lapini: Orestea Fabbri Editore) rinominata Etna dal tiranno, nel 476 a.C.
Se teniamo conto del fatto che Eschilo riesce a mettere in scena la tragedia I Persiani, otto anni dopo la vittoria dei Greci su questi, dovremmo dedurre che il medesimo tempo dovesse essere stato impiegato per comporre le Etnee, un’opera assai complessa, come si evince dai pochi frammenti giunti fino a noi.
Ma al di là delle considerazioni sui tempi d’incubazione necessari per realizzare l’opera, a noi preme comprendere lo scopo per cui questa opera venne commissionata al tragediografo greco e perché proprio a lui.
Per quanto assenti siano le fonti dirette, secondo una tradizione antica, Eschilo sarebbe caduto nell’accusa di aver divulgato i misteri di Eleusi ai quali era stato iniziato, e per questo aveva subito un processo in cui rischiava la condanna a morte.
Nonostante fosse stato prosciolto dall’accusa non facciamo fatica a credere vera questa tradizione se soltanto ci soffermiamo sui temi trattati nelle sue opere, impregnate di una religiosità della quale egli si erge a Ierofante. Tenuto conto delle implicazioni religiose avute in patria, supponiamo che Eschilo ricevesse l’incarico di comporre le Etnee con l’intento di operare un sincretismo tra la religione greca e quella siculo sicana. Crediamo che l’invito gli fosse giunto da parte di Gelone subito dopo la vittoria ottenuta sui Punici ad Imera nel 480 a.C., e dopo che il re aveva
messo in campo una serie di atti per riscuotere una captatio benevolentiae da parte dei Siculi. Come sopra affermato aveva promesso l’edificazione del tempio di Demetra nella città di Etna (Lib. XI, VII). Se, con la ricostruzione dei fatti qui sintetizzata, abbiamo colto nel segno, sarebbe lecito supporre che, il re, incoraggiato dal consenso manifestato nei suoi riguardi dalla città di Etna/Adrano, avrebbe incaricato il poeta, quale apparente atto di omaggio nei confronti della plurimillenaria tradizione sicula, di comporre il dramma. In realtà lo scopo che si prefiggeva il re, era quello nascosto di porre in essere un’operazione di sincretismo religioso fra le due etnie. Dunque Le Etnee sarebbe stata, secondo la nostra ricostruzione, un’opera dedicata alla città di Adrano (Etna) sede della casta sacerdotale detentrice della tradizione atavica. Non dunque, un’opera voluta da Gerone per celebrare la fondazione o rinominazione di Etna/Catania come asserito da qualche autore contemporaneo. L’ipotesi da noi sostenuta prende corpo se si riflette sul contenuto del dramma, ma non solo, come vedremo oltre. In essa gli Dei: Adrano, i Palici, Etna, componenti della famiglia divina Sicana, e, d’altro canto Zeus, prendono i moderni connotati di una famiglia allargata, nella quale: Zeus assume il ruolo di padre naturale dei Palici ed Adrano quello di padre spirituale. Il riferimento alla città di Adrano/Etna nell’opera eschiliana, è palese. L’equivoco in cui sono incorsi alcuni studiosi, per cui si crede che il contenuto dell’opera riguardi Catania, è dovuto al fatto che essa per un breve periodo assunse il nome di Etna. Infatti, sia il tema trattato: il concepimento dei Palici da Parte di Etna avuti da Zeus, sia il coinvolgimento del dio Adrano con sede nella città eponima, equiparato a Zeus, hanno come loro sede il territorio di Adrano (Etna) e non quello di Catania (Etna): l’ara degli dei Palici viene posta da Virgilio sul fiume Simeto, presso Adrano; I gemelli divini, assunta la forma di acque carsiche, perverrebbero successivamente alla luce, come riporta Macrobio, sotto le sembianze di fonti denominate metaforicamente acqua chiara e acqua scura, nella condrada Polichello che da loro prende il nome, presso la città di Adrano (Etna). Se poi, Gerone, avesse utilizzata a proprio beneficio e per fini auto apologeti, l’idea avuta probabilmente dal fratello e avesse voluto adattare l’opera in corso di componimento, alla recente conquista di Catania, é altra questione e del tutto secondaria rispetto alla magistrale operazione di sincretismo ideata dal re.
Che Le Etnee fosse un’opera destinata alla città simbolo della religiosità atavica, Adrano (Etna), emerge anche da un particolare messo in evidenza da Diodoro e passato inosservato per alcuni studiosi: la manifesta gioia di Gerone per aver ottenuto di poter installare una guarnigione siracusana nella città di Etna (Adrano) che egli rinomina in Innessa. La rinominazione di Etna in Innessa, suo primo e antico nome, ebbe lo scopo di far sì che Catania potesse, a sua volta, essere rinominata con il nome di Etna. Questa sciagurata operazione creo’ i presupposti per l’incomprensione di molti passaggi storici riferiti alle due città che portarono, seppure per un breve lasso di tempo, lo stesso nome, e ciò divenne l’occasione per i numerosi equivoci in cui incapparono molti storici antichi e moderni, incluso Diodoro vissuto quattro secoli dopo i fatti da lui narrati. Per comprendere il motivo per cui la ricchissima città di Innessa, governata dal grandemente amato re Teuto nel VI sec. a.C., come riporta Polieno nel suo componimento Stratagemmi, venne rinominata in Etna, consigliamo la lettura dell’articolo: Etna, un matrimonio illustre nella Adrano del VI sec. a.C..
Ad majora.
Adranodoro, ovvero la breve influenza adranita nella politica siracusana dal IV al III sec. a.C.
“In Sicilia la morte di Gerone
aveva mutato la situazione
per i Romani; il regno di lui, infatti, era
passato a Geronimo suo
nipote adolescente (…) successivamente Adranodoro (…) concentrò il potere di tutti soltanto nelle sue mani”.
T. Livio, Ab Urbe Condita, XXIV, 4
Ancora una volta, siamo certi, Stupirà i lettori il titolo di questo articolo. Vi esortiamo, tuttavia, a seguire la nostra indagine fino alla fine, se non altro per l’autorevolezza che ne deriva dal filosofo tedesco, Nietzsche, il quale affermando che anche un pazzo dice talvolta la verità, invitava il ricercatore ad aprire la mente ad ogni possibilità. Se poi, riflettendo sulle affermazioni dello storico Dionigi di Alicarnasso il quale sosteneva che non era opportuno raccontare ciò che non ritornava a vantaggio del prestigio dei Greci, si traessero le conclusioni che la verità non sempre viene servita in un piatto d’argento, ma va con fatica ricercata tra le pieghe della storia canonizzata, non si cadrebbe in errore. Se il greco Diodoro di Agira, ignorando o evitando di apprezzare il ruolo che ebbero grandi personalità non greche, quali furono Adranodoro, Soside e chissà quanti altri Siculi, nel determinare il destino della storia isolana, fosse da aggiungere a quegli storici rancorosi, accusati da Platone nel Minosse di raccontare i fatti non secondo verità, ma secondo utilità, non lo sapremo mai con certezza. Auspichiamo, dunque, che ognuno di noi sappia trovare da sé gli strumenti che le scienze e la storia mettono a disposizione, affinché riesca a fare chiarezza tra il crepuscolo dei millenni trascorsi.
Adranodoro: breve affermazione dei siculi a Siracusa.
Adranodoro era il genero del tiranno siracusano Gerone II che meritoriamente si era guadagnato il titolo di re in corso d’opera. Gerone morì nel 215 a.C., dopo cinquant’anni di buon governo grazie al quale era riuscito ad assicurare una grande prosperità sia alla città di Siracusa che a quelle, pochissime dopo il concordato fatto con i Romani nel 263 a.C., a lui sottoposte. La città di Adrano era fra quelle sottoposte all’influenza politico militare di Siracusa. L’influenza greca esercitata nei confronti della città sacra di Adrano, come la definisce Plutarco nella Vita di Timoleonte, era iniziata già nel 477 a.C. con la politica espansionistica di Gerone I, tiranno di Catania da lui rinominata in Etna, e della quale si dichiarò fondatore. In quella stessa occasione il tiranno si era accontentato di porre una guarnigione siracusana anche sull’acropoli di Etna, prima che questo nome passasse a Catania, e di cambiarle il nome facendole assumere quello primitivo di Innessa (vedi l’articolo Adrano il santuario dell’Avo). Il massimo dell’ingerenza politica e militare siracusana esercitata nei confronti di Innessa/Etna, lo si raggiunse nel corso del IV sec. a.C. grazie alla temerarietà del tiranno Dionigi il vecchio il quale, emulando il suo predecessore Gerone I, cambia il nome alla città che soltanto pochi anni prima, durante la riconquista di Ducezio, con la liberazione dal giogo siracusano ottenuta attraverso l’espulsione di Trasibulo, successore e fratello di Gerone I, aveva ripreso il nome di Etna.
Dionigi chiese e ottenne, secondo la ricostruzione da noi effettuata confrontando le diverse fonti storiche, dal senato di Etna, quale oggetto del compromesso stipulato tra le parti, al fine di togliere il pressante assedio posto alla città (400 a.C.) , che Etna ospitasse la solita guarnigione siracusana a controllo dell’acropoli e, inoltre, che accettasse di essere rinominata col nome di Adrano. Questa seconda proposta, per nulla gravosa, anzi, evocativa di forze ultrafisiche, ritornò ben accetta alla potente casta sacerdotale degli Adraniti. La città sacra di Adrano, essendo la sede del culto nazionale tributato all’Avo primordiale Adrano e custode del tesoro di alcune città sicule, era probabilmente protetta da una anfizionia. Tra le città che aderivano all’anfizionia non potevano mancare, a nostro avviso, le città sicule di Paliké e di Erbita, città che, secondo le nostre ricerche convergenti nelle tesi più volte esposte, erano guidate da principi sacerdoti: da Ducezio la prima; da Arconide la seconda come è riportato da Diodoro di Agira. Le due città sopra nominate, assieme a quella di Adrano formavano verosimilmente una triade a protezione del culto, delle tradizioni ataviche e, dunque, erano organizzate militarmente. La loro alleanza era cementata sulla base del culto atavico in esse celebrato, culto che riproduceva in terra il metafisico concetto di famiglia, riflesso di quella divina: nella città di Adrano si onorava L’avo della stirpe sicana; a Paliche’ i figli del dio Adrano, i Palici e ad Erbita la dea madre Hibla o Etna (?). A diletto del lettore apriamo una breve parentesi: riteniamo probabile che il culto tributato alla dea Hibla, prima che fosse trasferito a Erbita, come presupponiamo, avesse la sua originaria collocazione a Siracusa, successivamente soppiantato da quello della divinità greca Artemide. Si comprenderebbe, se così fosse stato, la presenza a Siracusa di un re il cui nome è strettamente collegato alla dea Hibla, Iblone (re sacerdote della dea Hibla? ). Ma della ricostruzione storica e della fondazione di Siracusa ci siamo occupati nell’articolo i Feaci e la fondazione di Sicher – usa. Pertanto, rinviando al suddetto articolo coloro che volessero approfondire l’argomento, noi ritorniamo ad occuparci dei prodromi che portarono i Siculi di Sicilia e i cittadini di Adrano in particolare, ad influenzare la politica siracusana dopo i fatti svoltisi nel IV sec. a.C.
Timoleonte: la battaglia di Adrano
Nel 344 a.C., Dionigi il giovane, che con la morte del padre aveva ereditato il potentissimo regno di Siracusa, imbevuto di filosofia, non avvezzo a praticare ingiustizie nei confronti del prossimo (Dionigi: un tiranno filosofo. ) cedette, nonostante si trovasse in condizioni militari più avvantaggiate rispetto ai suoi avversari: da un lato Iceta tiranno di Lentini che ambiva a governare pure Siracusa; dall’altro Timoleonte e le città alleate delle quali Adrano faceva parte, il proprio regno al condottiero greco per ritirarsi in esilio in Grecia dove sognava di vivere da filosofo tra filosofi. Dunque, Dionigi, avendo deliberatamente scelto l’esilio, e nel frattempo essendo stato sconfitto da Timoleonte il tiranno Iceta nella celeberrima battaglia di Adrano dove si consumò il prodigio del dio eponimo, egregiamente raccontato da Plutarco (op. cit.), a Siracusa viene eletta la democrazia. Ci sembra verosimile la deduzione secondo la quale le città che avevano preso parte alla liberazione di Siracusa: Taormina, Tindari ed Adrano, inserissero nei nuovi quadri politici della Polis e nel senato siracusano, a garanzia della tenuta democratica della città, città che era ormai divenuta incubatrice del temuto morbo della tirannide, dei propri senatori.
Se nel formulare la ricostruzione sopra descritta siamo nel giusto, appare plausibile la presenza, citata dallo storico latino T. Livio, a Siracusa nel 215 a.C., di Adranodoro avente l’incarico di tutore dell’adolescente Geronimo, nipote del defunto re. Il nome Adranodoro significa donato da Adrano (dal greco Ἀδρανός = [dio] Adrano e δῶρον= dono). Costui era il genero di Gerone II e di lui, purtroppo, nel racconto liviano non emerge il ruolo politico o sociale che potesse occupare a Siracusa durante il regno del suocero. Dai fatti narrati dallo storico latino, emerge però, che Adranodoro era, per dignità, secondo soltanto al re. Il lettore concorderà con noi se ipotizziamo che, grazie al campo semantico abbracciato dal nome, colui che ne era portatore non poteva non affondare le radici del proprio lignaggio in nessun altro luogo se non nella città del dio Adrano. Un greco, infatti, ancor più se appartenente alla casa regnante, non avrebbe potuto avere un nome barbarico quale era palesemente quello di Adranodoro. Affidandoci all’intuito, formuleremo l’ipotesi, a motivo del nome dell’illustre personaggio, che ad Adranodoro fosse stata affidata la carica di pontefice massimo della divinità sicula che si trovava a Siracusa e che ancora al tempo di Cicerone (Processo a Verre, IV, 128) veniva onorata con l’appellativo di Urio (l’antico, dal germanico ur). Soffermandosi sulla descrizione ciceroniana del culto riservato ad Urio, se davvero Adranodoro ne era il pontefice, non stupirà se la dignitas dell’amato da Adrano fosse seconda soltanto a quella del re. Ci si ricorderà, infatti, che Timoleonte, appena 140 anni prima la presenza di Adranodoro a Siracusa, trasferendosi da Adrano a Siracusa, aveva edificato in quest’ultima un tempio al dio sicano che lo aveva salvato dalla lama dei sicari nel tempio adranita, durante il sacrificio in onore del dio. Ma la presenza di Adranodoro nella reggia del re Gerone II, testimonia ancora altro: elementi aristocratici autoctoni o comunque non Greci – Adranodoro era, verosimilmente, uno dei numerosi principi sacerdoti Siculi al pari dei suoi predecessori quali erano Ducezio e Arconide, per citare soltanto i più famosi – erano riusciti ad inserirsi nei gangli del potere e avevano condiviso con gli elementi greci le politiche della Polis più potente dell’isola. Infatti, come lascia intendere T. Livio, Adranodoro alla morte del novantenne re, Insignito della carica di tutore dell’adolescente tiranno, sarà di fatto colui che governerà la potente città greca in luogo del quindicenne Geronimo, nipote di Gerone II. A questo punto della tesi elaborata sembra ovvia la deduzione secondo la quale se Adranodoro poté aspirare al ruolo di tiranno dopo il breve regno di Geronimo, vittima di una congiura, ciò dovette essere stato possibile soltanto grazie ad un vasto consenso ottenuto tra i ranghi degli aristocratici siracusani. Tant’è che il nostro, dopo l’assassinio del giovane tiranno, nei giorni immediatamente successivi, viene democraticamente eletto dal consiglio cittadino, tra i primi, pretore. Del resto, appare ovvio che dopo il colpo di stato perpetrato dal profugo di Corinto Archia, ai danni del pio principe siculo Iblone che lo aveva accolto da ospite quattro secoli prima I fatti qui narrati, nel 734 a.C., come abbiamo ricostruito e descritto nell’articolo sopra citato, la componente sicula pre-greca, quella successivamente appellata dei gamoroi e dei killiroi ( I Cilliri del Simeto) non fosse scomparsa nel nulla, ma fosse rimasta a fare da opposizione politica a Siracusa. I Siculi che continuarono ad abitare a Siracusa, relegati al ruolo di oppositori politici, che da sempre e in ogni modo, avevano osteggiato la tirannide al punto da riuscire a porre sotto assedio nel 405 a.C., nella sua stessa reggia, Dionigi, che in quel frangente preso da sgomento, si sarebbe perfino suicidato se il suo amico Filisto, poi diventato storico di corte, non lo avesse convinto a desistere, non abbandonarono mai la lotta per il ripristino della democrazia. Emerge dal racconto di Diodoro che, quando i Siculi di Siracusa cadevano in disgrazia militarmente o/e politicamente, essi trovavano sempre riparo nella città di Etna, pronta ad accoglierli, motivo per cui, non solo il legame tra la città di Etna e Siracusa era fortemente saldo, ma Etna (l’antica Innessa e la futura Adrano) aveva rappresentato una spina nel fianco per tutti i tiranni siracusani. Teodoto e Soside, nel racconto liviano appaiono, in quel lontano 215 a.C., quali congiurati del tirannicidio e portatori della democrazia a Siracusa. Ma, ahimè, la stirpe dei tiranni è dura a morire e a Damareta, figlia del re Gerone II e moglie di Adranodoro, mal si addiceva un ruolo che non fosse quello di regina. Mal consigliando il marito, l’aspirante regina lo indusse a indossare gli ancora insanguinati panni del nipote tiranno. “Adranodoro non disprezzò nel loro insieme i consigli della moglie” afferma Livio nel lib. XXIV, 22. Ma ciò gli fu fatale. Assassinato anche Adranodoro e con lui tutti i componenti della casa regnante, abbiamo buoni motivi per credere che Soside sia stato di etnia sicula e facente parte della stirpe di quell’altro Soside che nel 405 a.C. era tra coloro che assediavano Dionigi I nella sua reggia, e che, abbandonati dalla fortuna furono costretti a riparare in Asia e combattere come mercenari per Ciro (Senofonte, Anabasi). Soside, il contemporaneo di Adranodoro, scelse di aprire le porte della città di Siracusa ai romani (T. Livio ab Urbe Condita lib. XXVI) piuttosto che riconsegnare la Polis alla tirannide greca. Soside era certamente uno degli eredi di quegli aristocratici gamoroi, antichi oppositori di Archia mai rassegnati alla tirannide, a cui riuscì con la politica ciò che al suo antenato non era riuscito con la forza. Infatti, Livio sostiene nel libro XXV, 24, che dei Siracusani (Siculi?) militavano tra le file dei Romani e Soside precedeva Marcello trionfante, durante la celebrazione del trionfo a Roma.
Adrano: una breve egemonia.
Che giovani rampolli Adraniti si fossero inseriti nell’alta società siracusana non deve stupire considerato il prestigio che la città ebbe durante l’arco di molti secoli, se non millenni. Adrano, grazie alla presenza del santuario dedicato all’Avo, era oggetto di pellegrinaggio (Plutarco op. cit.), fonte di grandi ricchezze che indussero il temerario Falaride di Agrigento, come affermato da Polieno negli stratagemmi, a tentare una sortita nel tempio per impossessarsi dei forzieri. Il periodo Timoleonteo, in virtù della partecipazione importante, per non dire decisiva, di cittadini adraniti nella lotta di liberazione dell’isola dalle tirannidi, rappresentò una crescita economica che non ebbe pari nella storia della città sacra di Adrano. Tale crescita viene ben messa in evidenza dai ponderosi studi condotti dal dottor Sebastiano Barresi. Lo studioso si è occupato della produzione adranita di ceramica figurata siceliota. L’accademico avrebbe persino individuato una scuola di ceramisti Adraniti. Il mercato di questa ceramica, oltre che coprire quello della Sicilia orientale, si estendeva, secondo la tesi dello studioso, fin nelle isole Eolie (S. Barresi, Tra Etna e Simeto).
Vorremmo concludere questa breve ricerca con l’auspicio espresso dallo stesso Barresi: “Adrano, con il suo territorio, la sua storia ed il suo museo, nonostante le difficoltà poste alla ricerca dalla odierna realtà urbanistica e sociale del paese, per la sua ricca e complessa documentazione può rappresentare un campo di studio privilegiato in cui sperimentare metodi di analisi d’insieme e forme di indagine integrate”.
Ad majora.
Lo Sciamanesimo
Lo Sciamanesimo.
Il Neolitico tra Etna e Simeto.
Stupirà il titolo di questo articolo il lettore? Se egli ci ha attentamente seguito in tutte le tappe delle ricerche condotte fin qui e ha acquisito dimestichezza con il nostro metodo di approccio alla ricerca e all’investigazione, non lo crediamo. Inizieremo questo articolo ricordando a chi ci segue, che l’antico territorio di Adrano presentava caratteristiche tali da potere influenzare, indirizzare o stabilire un rapporto privilegiato con il fenomeno divino, al punto che gli antenati, consci che lo spazio non è omogeneo, ma presenta delle rotture dentro le quali si manifestano fenomeni non comprensibili dalla mente razionale, vi edificarono un tempio, un tempio caro a tutti gli abitanti dell’isola. Era, questo tempio, o più verosimilmente un’ara, dedicato all’Avo primordiale Adrano. Si ricorderà il lettore, che in altri numerosi nostri articoli erano state descritte le caratteristiche che rendeva particolare la casta sacerdotale deputata al culto dell’Avo. I componenti di questa erano definiti gli evocatori del furore dell’Avo, cioè Adraniti. Ma poiché, come è ovvio che sia e come sempre presumiamo sia stato, la religiosità scaturisce da quel moto dello spirito individuale che si manifesta con modalità differenti, è plausibile che ognuno la viva a modo proprio e, a volte, fuori dai parametri canonizzati da secoli di trasmissione. Fu per tale irrequieto moto spirituale, infatti, che sorsero gli ordini monastico cavallereschi nel Medioevo; per tale sentimento si fecero strada forti personalità che preferirono portare all’estremo l’esperienza di vita attraverso il romitaggio; e così avvenne pure per quella categoria, forse la più antica fra tutte quelle apparse sulla terra, gli sciamani, scomparsi nel tecnologico, evoluto, emancipato occidente, ma ancora molto attivi in centro America, Africa ed Europa dell’est. Di quest’ultimi abbiamo scelto di occuparci nell’arduo tentativo di comprendere e ricostruire meccanismi antropologici che caratterizzarono il territorio preistorico non soltanto etneo. Ebbene, abbiamo motivo di credere che questa categoria di sensitivi fosse stata presente in Sicilia dagli albori del mondo fino all’età del bronzo, per poi sparire, sopraffatta verosimilmente dalla raffinata organizzazione di una casta sacerdotale che, emulando l’organizzazione a cui era approdata la casta guerriera, tentava di darsi un proprio assetto gerarchico. Pertanto, la realizzazione di questo ambizioso progetto non prevedeva la presenza di “ostacoli” in corso d’opera che lo impedissero, lo ritardassero o lo modificassero.
Ma tornando all’argomento dello sciamanesimo praticato là dove il culto primigenio, quello dell’Avo Adrano, molte migliaia di anni prima dell’era volgare si impose nell’isola con l’apparire dei Sicani, bisogna affermare che non si riuscirebbe a comprendere del tutto il fenomeno senza il soccorso di diverse discipline scientifiche.
Infatti ognuna di esse tornerà utile per colmare le lacune che inevitabilmente si riscontrano analizzando un così ampio arco temporale, cioè quello che faremo iniziare con il ritrovamento dei più antichi reperti archeologici che corrispondono al neolitico, fino all’età del bronzo.
I REPERTI DEL VII MILL. a.C.

I più antichi reperti ritrovati nel territorio adranita sono stati datati dagli studiosi al VII mill. a.C. Ma poiché esistono reperti ancora più antichi in Sicilia, come le pitture e le incisioni rupestri dell’Addaura e di Cassibile, risalenti al 20.000 a. C., la presenza di una tale raffinata cultura ci induce ad ipotizzare che, non solo questa civiltà sia più antica della data riportata, e ciò dovuto al motivo di un periodo di incubazione della stessa, ma che anche il territorio adranita fosse stato antropizzato fin da quella data pur non avendo ancora rinvenuto reperti ad essa riferibili. Ma ciò rimane tuttavia un argomento di second’ordine rispetto alle tesi che formuleremo qui di seguito.
Il 7.000 a.C. rappresenta un periodo in cui è possibile rintracciare, in aree geografiche distanti tra loro, numerosi punti di contatto. Citeremo quale esempio la evolutissima cultura di Mergahrt in Pakistan, di Alaca Huyuk in Anatolia, ed ancora di Moenjo-daro e di Harappa poiché nel nostro museo archeologico, ospitato nelle prestigiose sale del castello costruito dagli Altavilla nell’XI sec., si conservano reperti di terracotta, di cui diremo più giù, sui quali vi sono impressi simboli che riconducono alle culture su citate.
Ma torniamo all’esamina del territorio di nostra pertinenza. Tutto attorno al nucleo abitativo della Adrano neolitica in cui sorgeva il santuario, omphalos della collettività, verosimilmente abitato soltanto da sacerdoti, vi fu un lungo periodo di antropizzazione senza soluzione di continuità, protrattosi a cominciare dal neolitico fino all’età del bronzo come si evince dagli studi della dottoressa L. Maniscalco pubblicati sulla rivista Tra Etna e Simeto. Nel corso del II millennio a.C., venne a modificarsi, secondo le nostre ipotesi, la geografia dell’antropizzazione del territorio. Infatti, del periodo successivo all’età del bronzo antico non verrà più rinvenuto alcun reperto in situ.
Il motivo del grande cambiamento potrebbe essere stato causato, secondo la nostra ricostruzione, dai rumori di guerra che giungevano dall’oriente, causati dagli appetiti di conquista di quei popoli nei confronti dei vicini, Sicilia inclusa, dei quali l’episodio di Minosse re di Creta, giunto in Sicilia per assoggettarla, é forse soltanto il più noto giunto fino a noi. Gli abitanti dei circa dieci villaggi sorti nei pressi del tempio dell’Avo Adrano, ritenendo che questi fossero poco difendibili (vedi l’articolo: il pagus è il territorio. Adrano antica) li abbandonarono aggregandosi attorno alla fortezza naturale della Rocca a sud dell’ampio territorio adranita. Qui, come già detto, sorgeva il tempio edificato sull’acropoli ed il villaggio, verosimilmente abitato dai soli addetti al culto e dagli inservienti. Come d’uso in quell’epoca il tempio doveva essere circondato da un recinto sacro costituito da un alto muro. Il recinto era edificato con enormi pietre poligonali sovrapposte, e dovrebbe coincidere con quello ancora esistente in C.da Difesa. Il tempio era circondato da un esteso bosco sacro attraversato da ruscelli. In esso pascolavano allo stato semi brado le vittime selezionate per il sacrificio. Duemila anni dopo l’epoca qui analizzata, Eliano, rifacendosi a Ninfodoro, potrà affermare che vi era la presenza di mille cani a guardia del tempio. L’acropoli così descritta, con molta probabilità avrebbe conservato la caratteristica di una cittadella, una città nella città, come appariva al visitatore l’acropoli di Atene e il Campidoglio a Roma. Plutarco, nella vita di Timoleonte nel definire città sacra Adrano, aveva forse in mente la cittadella dell’acropoli. Con il trasferimento dei cittadini dei villaggi limitrofi nel nuovo sito si ritenne probabilmente necessario ampliare la fortezza preesistente dell’acropoli, realizzando così una doppia cerchia muraria. Il villaggio dunque, si era adesso trasformato in una città con un numero di abitanti che variava da quindici a venti mila individui (per la formulazione di quest’ultima tesi consultare l’articolo: I Sicani in Adrano: il pagus è il territorio) numero notevole per quei tempi. Prima che avvenisse il radicale cambiamento, é probabile che al culto ufficiale tributato all’Avo, gestito dai sacerdoti, nei villaggi vicini in seguito abbandonati, si affiancasse una pratica gestita da figure enigmatiche, una pratica che fosse una via di mezzo tra il magico e il religioso. A loro volta questi manipolatori di forze extrafisiche assumevano un ruolo che stava tra lo psicopompo, il taumaturgo, il prete; abbiamo descritto l’antichissima figura dello sciamano.
Interrotta la vita del villaggio, come affermato sopra, non accettati dalla casta sacerdotale ufficiale che deteneva il monopolio del sacro e condivideva quello politico con il principe e il senato degli anziani, gli sciamani si ritrovarono sempre più emarginati nella società e mano a mano si estinsero.
Riparo Cassataro. Lo Sciamano di Adrano.

Tollerati all’inizio e, come ipotizzato sopra, emarginati in seguito, nel nuovo centro urbano formatosi dalla riunione dei villaggi circostanti, questa obsoleta categoria di individui ebbe vita difficile: degli sciamani, non oltre la decina, qualcuno scelse di vivere in romitaggio, altri si adeguarono al nuovo corso degli eventi fino all’estinzione. Ci chiediamo: fu uno di questi ultimi sopravvissuti sciamani a dipingere con l’ocra rossa le figure su una delle pareti della roccia di arenaria del Riparo Cassataro? Il luogo ove potrebbe essere vissuto il presunto eremita, luogo in cui fu rinvenuto l’unica sepoltura di cui diremo oltre, presenta infatti le caratteristiche morfologiche e paesaggistiche ideali per ottenere gli stati di estasi attraverso i quali lo sciamano raggiungeva la dimensione ultramondana. Infatti, questo luogo caratterizzato dalla presenza di due enormi rocce poggiate l’una sull’altra, sembra formare un utero dentro al quale lo sciamano, durante gli stati alterati di coscienza, sarebbe potuto ritornare allo stadio prenatale.
Se siamo giunti ad avanzare una così “bizzarra” tesi lo dobbiamo alla grande mole di indizi che abbiamo trovato a suo supporto e che continueremo ad elencare in seguito.
Comparazione e analisi dei reperti neolitici.
Il primo indizio che ci ha indotto a formulare la tesi esposta consiste nel ritrovamento, in C.da Fontanazza, nelle vicinanze del Ricovero Cassataro, di uno scheletro – si tratta, come affermato, dell’unica tomba scoperta nel villaggio neolitico di Fontanazza – colorato con ocra rossa. Il corredo funebre deposto accanto allo scheletro era poverissimo, cosa che ben si adatta ad una vita vissuta nel modo più austero possibile quale era quella vissuta da monaci, sciamani, filosofi di ogni epoca. La ceramica sparsa nel villaggio in cui si rinvenne lo scheletro era impressa con decorazioni che in una ottica più laica viene valutata quale una prima forma di scrittura ideografica o comunque un simbolismo che veicolava concetti di ordine metafisico. Gli studiosi fanno risalire la ceramica impressa al periodo neolitico (Laura Maniscalco Tra Etna e Simeto). Lo scheletro, come affermato, era stato trattato con ocra rossa, anche i dipinti del Riparo Cassataro erano stati realizzati utilizzando questo minerale ferroso. L’ocra rossa è stata utilizzata anche per le pitture che si trovano sulle pareti delle grotte paleolitiche di molti luoghi in Europa. Pech Merle, in Francia, risalente a venticinquemila anni fa é solo una tra le tante. Lo scheletro, come affermato, è stato ritrovato nella contrada Fontanazza, adiacente al Riparo Cassataro, dentro ad una fossa ellittica ( recinto sacro? I druidi durante le loro pratiche rituali, prima di iniziare, tracciavano col lituo, un cerchio attorno.) foderata di lastroni, con frammenti di ceramica a decorazione impressa, tra essi una ciotola – oggi, forse, grazie ad un nuovo approccio nei confronti della ricerca e una diversa valutazione delle conoscenze scientifiche possedute nel mondo antico, da parte degli studiosi, si sarebbe stati più attenti al contenuto della ciotola, se ve ne fosse stato, e, analizzato, chissà, magari si sarebbero potuti trovati i resti di sostanze psicoattive. Infatti, è appurato che gli sciamani di tutte le coordinate geografiche del mondo, per favorire i loro viaggi extracorporei utilizzavano piante psicoattive: dal peyote del centro America, all’ayahuasca dell’Amazonia -.

Il Riparo Cassataro si trova sulla riva destra del fiume Simeto, ad un centinaio di metri dal suo letto. Ma quello che assume ai nostri occhi l’importanza di un indizio è dovuto alla presenza dell’ocra rossa sullo scheletro dell’illustre defunto. Infatti, questo minerale viene utilizzato per veicolare, in termini simbolici e metafisici, il valore del sangue vivificatore del corpo. Esso, utilizzato sullo scheletro, assume il valore di auspicio per una rinascita dopo la morte. Un indizio ulteriore che ci porta a formulare l’ipotesi sopra esposta circa la frequentazione di luoghi carichi di forze, ce lo fornisce Cicerone nel De Divinazione. Il famoso romano, che al suo tempo fu pretore anche in Sicilia, faceva un lungo elenco delle nazioni straniere in cui saggi, sacerdoti, re, uomini di stato, si recavano per un periodo di tempo in luoghi isolati fuori dalla città, per meditare. Presso il popolo Veda, il re, in vecchiaia, quando percepiva l’approssimarsi della propria fine, abbandonava il proprio regno consegnandolo all’erede, per recarsi fra le montagne dell’Himalaya dove, vivendo da eremita dentro una delle numerose grotte montane, attendeva la morte.
Significato del simbolismo dipinto nel ricovero Cassataro.
I dipinti sulla parete del rifugio, rimangono non soltanto enigmatici, ma persino sulla loro datazione i pareri degli studiosi sono discordanti. La dottoressa L. Maniscalco avvalendosi del metodo comparativo propone per i dipinti la datazione del neolitico medio. Lasciando la disquisizione cronologica agli accademici, noi ci occuperemo del rebus che circonda le pitture in questione. Lasciando sospesa la difficile interpretazione della figura umana presente sulla parete che potrebbe rappresentare lo stesso sciamano protagonista del dipinto e la metafora, a motivo della inarcatura delle braccia sui fianchi, della danza circolare che egli compie, e quella che riguarda le altre figure sbiadite dal tempo, ci soffermeremo sul disegno del reticolo ad alveare. Dipinti reticolari appaiono in diverse pitture parietali di grotte distribuite in varie parti del mondo; a Catal Huyuk per esempio, in Anatolia. Il sito di Catal Hujuk è, probabilmente, da identificarsi con una necropoli, una “città dei morti” risalente al 7.000 a.C. Le case o cappelle ivi costruite, in alcune delle quali vi sono contenute le ossa dei defunti e in altre simboli cultuali, sono tutte unite tra di loro, appoggiate l’una all’altra, parete contro parete, senza alcun corridoio che separi l’una cappella dall’altra, insomma, un reticolo impenetrabile in cui l’accesso ad ogni camera era consentito soltanto attraverso una apertura praticata nel tetto, e grazie ad una scala che conduceva dall’apertura alla Camera funeraria.
Ci chiediamo: avrebbe forse indicato anche nel Ricovero Cassataro, quel reticolo dipinto in ocra rossa sulla parete, una dimensione ultraterrena? Quella dei morti? Nella quale lo sciamano, durante i suoi viaggi fuori dal corpo sarebbe dovuto entrare in contatto con i defunti? Presso gli sciamani jacuzzi della Siberia, lo sciamano, nell’intraprendere il suo viaggio nell’aldilà, nel regno dei morti, si affida allo spirito guida dei propri familiari defunti: al nonno (non è un caso che nella teogonia delle civiltà antiche vi sia sempre il riferimento al nonno quale capo e protettore della stirpe. Il lessema nonno viene reso in alto antico tedesco con il termine Ano. Ur-Ano, Jah-Ano, Odhr-Ano, Ano… per Greci, Latini, Sicani, Sumeri.. ebbero tale ruolo.
Lo sciamanesimo nell’antica Grecia.
Ad un viaggio nel regno dei morti intrapreso dai vivi si fa riferimento sovente nella letteratura greca. Il viaggio nell’Ade rappresenta una tappa necessaria per coloro che anelano di conoscere il futuro. Nelle narrazioni greche, oltre al riferimento di diverse figure incontrate dal viaggiatore, non è mai assente la figura chiave del congiunto defunto: ad Ulisse, che ha il padre ancora in vita, appare “ l’indovino” Tiresia e comunque in contemporanea a questi la madre; a Dante, da buon esoterista qual’era, farà da guida il padre spirituale Virgilio; ad Enea appare il padre Anchise, garante della stirpe, anch’egli guiderà l’eroe e la ninfa che lo accompagna.
A proposito del viaggio di Enea nell’oltremondo, non ci sembra fuori luogo aprire qui una parentesi. Infatti ci sembra alquanto sospetto ciò che viene affermato nel sesto libro dell’Eneide in cui, Enea, assecondato nella sua richiesta dalla Sibilla – sciamana(?) – viene invitato a cercare una pianta che, una volta trovata, consentirà ad entrambi di scendere nell’Ade. Infatti, come emerge alla fine del VI libro, nell’oltremondo l’eroe viene accompagnato dalla Sibilla o sciamana. Vediamo ora come Virgilio descrive la pianta: essa ha delle bacche gialle e cresce sui tronchi delle querce. Coincidenza vuole che anche i druidi, che credevano nella sopravvivenza dell’anima dopo la morte del corpo, raccoglievano il vischio che cresceva sulla corteccia della quercia o verosimilmente, raccoglievano la pianta appena descritta. Che quello dell’eroe greco possa essere stato un viaggio onirico indotto da sostanze psicogene, lo conferma, tra le righe, lo stesso Virgilio alla fine del VI libro, quando descrive le due porte per le quali si accede al sogno: per l’una si accede ai sogni veri, per l’altra a quelli falsi.
Ma anche alcune pratiche apparentemente religiose riscontrate in Grecia sembrano alquanto simili a quelle sciamaniche a noi note. Le danze frenetiche praticate al suono martellante del tamburo durante i riti bacchici avevano lo scopo di provocare una rottura nello stato di coscienza del danzatore per entrare in uno stato di trance. Le frenetiche danze al suono del flauto, lo strumento del dio Pan, divinità del caos e della frenesia orgiastica, osservate da Senofonte durante l’attraversamento della Paflagonia e raccontate nell‘Anabasi, sembra si pongano sullo stesso piano. Non meno sospetta ci appare la danza in circolo che Orfeo impone ai più giovani fra gli Argonauti. Il suo fine, a detta del narratore, ha lo scopo di fare cessare la tempesta consentendo alle navi di salpare per la Colchide. Orfeo, suonatore di lira, lo strumento che emana note armoniche, in quella circostanza fa battere con forza le spade sugli scudi. Da allora, afferma l’autore del poema, Apollonio Rodio, i Frigi onorano Rea col suono di trottole e tamburi. La danza dello sciamano Orfeo – secondo quanto tramanda la mitologia anche lui avrebbe intrapreso un viaggio nel regno dei morti-, ci ricorda la Danza del Sole praticata dalla tribù dei dacota, in America, durante la quale si ottengono visioni. Anche i magar del Nepal utilizzano strumenti a percussione per raggiungere il mondo degli spiriti grazie ad una alterazione della coscienza. Mezzi alternativi alle piante psicoattive, oltre alle danze accompagnate da ritmi frenetici, possono essere l’iperventilazione, il digiuno, la privazione del sonno, la disidratazione. Per mezzo di droghe, piante psicogene o danze frenetiche lo scopo che raggiunge lo sciamano vuole essere il medesimo: un viaggio nel mondo degli spiriti ritornato dal quale, come hanno osservato studiosi occidentali che hanno osservato il fenomeno, lo sciamano dipingeva sulle pareti rocciose le scene che avevano visto nel loro viaggio.
Sa. Man ovvero il conoscitore.
Nel tentativo di ricostruire un periodo storico e culturale così lontano nel tempo, abbiamo intrapreso un percorso circolare per finire, citando Senofonte, nel luogo in cui la pratica dello sciamanesimo o, rifacendoci ad Apollonio Rodio, della magia, persistono ininterrottamente dai suoi inizi fino ai giorni nostri: la Siberia. Già la vicina regione della Georgia (si pensa che questa regione corrisponda alla mitica Colchide) come anticipato sopra, veniva citata da Apollonio rodio nelle Argonautiche per essere stata la patria delle maghe Circe e Medea, quest’ultima nipote della prima. Il termine sciamano lo si fa derivare dalla lingua tungusa, passato successivamente a quella russa con il termine saman.
La parola “sciamano” deriverebbe dalla lingua tungusa e indica qualcuno che sa. Pur rimanendo d’accordo sul significato, non concordiamo circa la sua derivazione. Il termine deriverebbe, a nostro avviso, dalla lingua germanica e risulta composto dall’unione dei lessemi sa dal verbo sehen vedere, nell’accezione metafisica di conoscenza, e dal nesso consonantico mn (riscontrabile nel teonimo Mnemosine) mente, liberamente traducibile con colui che vede con l’ausilio della mente. Calza perfettamente a tal proposito quanto affermato da Pausania circa l’antro della Beozia attraverso il quale si accedeva agli inferi. Prima di entrarvi bisognava bere a due fonti: una chiamata Lete, la dimenticanza (della vita vissuta), l’altra Mnemosine per ricordare ciò che si sarebbe visto nell’aldilà. Ma al di là del dibattito semantico sul termine sciamano, a noi preme stabilire la correlazione tra questa categoria di sensitivi nei diversi luoghi geografici e la produzione dei disegni a loro attribuiti negli stadi di trance: scale, reticoli, rombi, quadrilateri, zigzag, figure teriantropiche ecc.
Il terzo occhio.
Concluderemo la nostra ricostruzione con l’analisi di un frammento di ceramica ritrovato fra il misero corredo funebre dello scheletro ocrato che si collega al concetto di mente e alla sua capacità di vedere oltre. Il frammento presenta, realizzato attraverso la tecnica della impressione, un occhio romboidale. Ci chiediamo: possiamo considerare, a motivo del simbolismo riprodotto, questo frammento un ulteriore indizio a carico della tesi sopra esposta? Nell’immaginario collettivo (o dovremmo dire fra le consapevolezze degli antichi?) appartenente a molti popoli antichi si era fatta strada l’idea che vi fosse un terzo occhio, non umano, l’occhio onnisciente che ritroviamo nella iconografia di diverse civiltà antiche, avrebbe permesso a pochi individui dotati di particolari sensibilità, di attivarlo, di “vedere’ ciò che l’occhio umano non avrebbe potuto vedere. Era questo un vedere metafisico. Alcune frange di Indù sono ancora talmente convinti di questa asserzione che dipingono di “rosso” un cerchietto opportunamente praticato sulla loro fronte, imitando (o evocando) la presenza di un terzo occhio. Gli scienziati, da un altro canto, cominciano a scoprire le incredibili e numerose funzioni a cui la ghiandola pineale, che si trova nell’ipotalamo, sarebbe deputata. Una di queste funzioni consiste nel fare interagire il corpo con la mente favorendo uno stato meditativo di quest’ultima. Alcuni studiosi si sono spinti ad ipotizzare, proprio per le straordinarie caratteristiche appartenenti alla ghiandola pineale, che il terzo occhio possa essere la trasposizione mitologica di questa ghiandola dalla forma di una pigna (il rombo impresso nella ceramica neolitica?) di cui si trova una copiosa iconografia in tutti i popoli e in diverse epoche.
Ad majora.
I Sicani: Hiberia e Trinacria – Adraño: Un Dio Indoeuropeo.
I primi abitatori dopo di loro sembra siano stati i Sicani,
a loro dire anteriormente ai Lestrigoni e ai Ciclopi per il fatto
che erano autoctoni, mentre secondo verità erano Iberi scacciati
dai Liguri dal fiume Sicano nell’Iberia.
Tucidide, La guerra del Peloponneso, libro III,2
Trattando dei Sicani, non si può prescindere da quanto viene affermato in proposito dallo storico ateniese Tucidide. Egli, infatti, sebbene abbia attinto certamente da altre fonti, a noi non pervenute direttamente, è l’unico storico che fa cenno, seppur con una eccessiva semplificazione dovuta al suo esclusivo interesse alla guerra combattuta dai Greci in Sicilia, ad un passaggio del popolo sicano dalla Spagna alla Sicilia. Se lo storico ateniese avesse saputo che i Sicani erano stanziati, nello stesso periodo, anche nel Lazio, forse avrebbe mutato il suo giudizio in riguardo. Avrebbe, piuttosto, valutato la possibilità che questo popolo indoeuropeo, provenendo dal nord Europa, giunto alle Alpi, barriera naturale per l’ingresso nella penisola italica, si sarebbe potuto dividere, come infatti avvenne più tardi nel 110 a.C. per Cimbri e Teutoni, ed in molte altre occasioni, in due o tre tronconi: uno di questi avrebbe scelto di intraprendere la via verso l’Italia, anticipando di millenni Annibale che vi trovò, durante la sua attraversata delle Alpi gli eredi di quei primi pionieri, parte del quale, a sua volta, si sarebbe stanziato nel Lazio e parte avrebbe proseguito fino in Sicilia; l’altro troncone, continuando il suo percorso, si sarebbe potuto dirigere verso occidente lasciando a sua volta pezzi per strada: in Gallia dove vengono citati da Cesare nel suo trattato, La guerra gallica, qui li ritroviamo con il nome di Sequani, e poi, finalmente in Spagna citati da Tucidide. Poiché le affinità riscontrate tra i Galli Sequani e gli Italici Sicani sono state messe in evidenza in altre nostre pubblicazioni, qui, per motivi di sintesi, ci occuperemo delle affinità tra i Sicani spagnoli e quelli siciliani dimostrando, attraverso l’ausilio di prove oggettive, l’apporto di discipline scientifiche quali la comparazione, l’etimologia ecc. come è giusto che si richieda al ricercatore, che i due rami sopra nominati, pur facendo parte del troncone iniziale emigrato durante l’ultimo periodo interglaciale verificatosi intorno al diecimila a.C., percorsero vie separate, come sopra descritto, portando con se il patrimonio culturale comune; patrimonio conservatosi con irrilevanti varianti dovute ad adattamenti locali, fino al secondo millennio a.C. per poi sparire sotto il grave peso della sovrapposizione di differenti culture sopraggiunte dall’Africa e dall’oriente.
ADRANO IL SANTUARIO DELL’AVO SICANO
Se da un lato Tucidide era dunque in errore nel prendere in considerazione una migrazione avvenuta dalla Spagna verso la Sicilia, dall’altro lato, come affermato sopra, era nel giusto quando sosteneva che i Sicani abitassero la penisa iberica in tempi remoti. Infatti, come sopra accennato e come constateremo nei dettagli più giù, i Sicani raggiunsero la Spagna seguendo la costa atlantica con delle inbarcazioni e provenendo dall’estremo nord Europa. Questa tesi viene in parte provata dal fatto che nella parte nord occidentale della Spagna, al confine con il Portogallo, non lungi dalla costa atlantica, esiste un fiume che si chiama Río de Adraño. Il fiume in oggetto scorre presso un villaggio, anch’esso chiamato Adraño, divinità sicana per antonomasia. Il fiume potrebbe altresì essere stato considerato dai Sicani una divinità fluviale quale era lo Spercheo per gli abitanti di Ftia. Quest’ultima ipotesi potrebbe essere plausibile se si prende in considerazione il ritrovamento di una moneta adranita, in Sicilia, proveniente dalla omonima città di Adrano edificata sotto le falde dell’Etna, nella quale viene raffigurata, nel dritto, la testa di una divinità cornuta, fatta corrispondere dagli studiosi alla divinità fluviale (fiume Simeto?) e nel rovescio una lira con la scritta in senso destrorso adranitan. Comunque sia, appare già, a motivo della presenza speculare di due città che portano lo. stesso nome, inevitabile dal punto di vista culturale e linguistico, l’accostamento parenterale tra i Sicani della Spagna preistorica e quelli coevi della Sicilia, attribuendo al concetto di coevo un lasso di tempo cronologico abbastanza esteso essendo quella sicana una civiltà plurimillenaria che, per lo meno in Sicilia, vi abitò ininterrottamente e omogeneamente fino alla prima metà del II millennio a.C. Non possiamo far passare inosservata, onde suffragare la tesi della molteplicità delle fasi migratorie intraprese nel tempo univocamente dai popoli del nord Europa e, dunque, dal popolo sicano considerato un ramo di questi, la presenza del fiume Adrana oggi Eder, in Germania. La presenza di un fiume col nome di Adrana in Germania, luogo quest’ultimo in cui maggiormente si è conservata l’affinità con la lingua parlata dal popolo sicano, come abbiamo evidenziato nell’articolo , Jam akaram la lingua dei sicani, ritornerà utile al fine di comprendere il significato degli appellativi apposti a uomini, fiumi, città, dai popoli del nord. Tacito, raccontando delle gesta del generale romano Germanico e delle sue legioni, fa riferimento a questo fiume attraversato non senza difficoltà dalle legioni. Nel corso della spiegazione circa la formazione dei nomi presso i popoli nord europei, il lettore tenga conto che il sostantivo Ano, che forma il nome composto Adrano, ritorna ancora nel Lazio, regione abitata dai Sicani, a comporre il teonimo sicano Jah-Ano ovvero Giano bifronte. La formazione dei nomi presso i popoli germanici, allora come oggi, avveniva attraverso l’accostamento di più lessemi. Questi potevano essere più sostantivi; un aggettivo e un sostantivo; una preposizione e un sostantivo; un verbo e un sostantivo. Nel caso specifico, i teonimi del siciliano Adrano e del laziale Jahano, ai quali potremmo aggiungervi quello del greco Urano, dell’iraniano Mani, del germanico Manno, dell’indiano Manu ed infine del mesopotamico Anu, sono riconducibili ad una semantica del divino ove l’aggettivo che precede il sostantivo Ano serve a determinare la caratteristica dell’Avo, una dote o una virtù che, posseduta dall’antenato, avrebbe consentito a questi, capostipite della stirpe sicana[1] , una volta morto, di superare le prove che gli dèi gli avrebbero posto durante il tragitto nell’aldilà, superando le quali sarebbe stato ammesso al consesso degli dèi e a loro si sarebbe reso simile. Divinizzato grazie al superamento delle prove, l’Avo avrebbe, da quel momento, rappresentato il protettore della stirpe. A loro volta, nel loro rigore religioso, i Sicani ritenendosi unici eredi di cotanto antenato, sarebbero divenuti i detentori del sapere, della via mostrata loro direttamente dall’Avo.
Abbiamo constatato, nel corso delle nostre indagini, come sopra affermato, che con il nome Adrano viene frequentemente indicato un fiume, motivo per cui alcuni ricercatori accostarono l’etimo al significato di acqua, Adrano era cioè, secondo l’opinione di questi studiosi, da identificarsi col dio delle acque, ma come vedremo le cose non stanno in questo modo. In Sicilia vi è un caso di analogia incredibile con la Spagna, come messo in evidenza sopra; infatti in entrambi i luoghi il nome Adrano indica due città e ivi vi scorrono due fiumi o nel caso siciliano, che vi scorreva, essendosi prosciugato, come si evince dallo storico siculo arabo Idrisi il quale fa riferimento ad un fiume che scorreva nella città di Adrano. In Germania, la conversione del nome del fiume Adrana citato da Tacito, nell’attuale Eder, potrebbe trarre origine da una modificazione linguistica avvenuta nel tempo, per cui l’aggettivo Odhr che indica la caratteristica impetuosa del fiume, si sarebbe trasformato in Eder (Edhr?). Il fiume, infatti, potrebbe essere stato aggettivato, a motivo dei fragorosi flussi causati dalle potenti correnti che lo facevano scorrere con violenza, semplicemente “il furioso”, cioè “odhr”. Che l’aggettivo Odhr possa tradursi con furioso lo spiega lo storico germanico Adamo da Breda che scrisse una storia sui Goti, popolo questo proveniente dalla Scandinavia, odhr, tra l’altro, afferma lo storico, è uno dei tanti appellativi che venivano utilizzati per caratterizzare Odino, il dio degli scandinavi, divinità che con quella sicana di Adrano, come abbiamo dimostrato in diverse occasioni, aveva numerose affinità. Di conseguenza, il nome del dio Adrano, liberamente traducibile con “l’Avo furioso”o “il furore dell’Avo”, prenderebbe origine non dall’elemento acqua, ma dalla furia con la quale essa, nei fiumi, scorre nel proprio alveolo e più elasticamente può ritenersi che l’aggettivo odhr, furioso, sia scaturito grazie alla modalità piuttosto violenta con la quale la divinità si manifestava. L’aggettivo furioso riferito all’Avo, unico caso in cui viene utilizzato, lo si ritrova soltanto in Sicilia, terra in cui la “furia” dell’Avo si manifestava, per i primi abitatori, i Sicani, in mille modi: dai frequenti terremoti provocati dal vulcano Etna ai suoi paurosi boati; dalle lunghe devastanti colate laviche, alle stesse che giungendo fino al mare lo facevano ribollire per finire, in ultimo, con la madre di tutte le catastrofi: l’implosione del vulcano che provocò un terribile maremoto e la grande voragine della valle del bove. Le onde provocate dal cataclisma, verificatosi secondo le stime dei geologi intorno al quattromila a. C., avrebbe sommerso le città costiere della Palestina. I resti delle città sommerse sono stati in parte rinvenuti dagli archeologi subacquei. Non è infatti un caso se il tempio dedicato all’Avo furioso, come afferma lo storico Diodoro, si trovasse sotto le pendici del vulcano, e, come supponiamo noi, su una estesa pianura lavica ove oggi sorge la vetusta Adrano ed un tempo vi scorrevano fiumi che formavano fragorose cascate le cui tracce ancora visibili, ci hanno consentito di ricostruirle assieme al territorio circostante, attraverso la realizzazione di un plastico in scala 1:1000 visitabile dal pubblico. Che tra l’Avo sicano e le acque, intese come elemento, non vi fosse alcuna relazione lo si evince dal fatto che nelle diverse aree geografiche in cui venne tributato il medesimo culto, per caratterizzare la divinità vengono utilizzati i più svariati aggettivi che rispondono a esigenze di adattamento culturale locali: jah, il sensitivo, il rapido, il percettivo nel Lazio; ur, l’antico, il primordiale in Grecia; man, la mente nella accezione di potenza creatrice in Germania ecc .
Desideriamo ricordare ai nostri lettori, se pur non vi sia una relazione apparente con il tema trattato in questo articolo, che la città di Adrano viene rinominata con il teonimo sicano, da Etna che si chiamava, soltanto nel IV sec.a.C. La rinominazione fu probabilmente dovuta ad un compromesso avvenuto tra il tiranno Dionigi I che assediava la città di Etna e i suoi abitanti. Infatti, servendosi del nome della divinità nazionale sicana per la rinominazione di Etna, concordato con gli abitanti di Etna, il tiranno siracusano si proponeva come scopo, quello di lasciare intendere che nella città sicana, -definita sacra da Plutarco (Vita di Timoleonte) definizione che ci ha indotto a ritenere che la città fosse, sul modello di quella greca di Delo, protetta da una anfizionia di città sicule- vi fosse subentrata semplicemente una influenza politica e militare siracusana, la quale non avrebbe minimamente inciso né sul culto né sulla cultura sicana, (vedi l’articolo, Alesa. Da Vercingetorige ad Arconide). Che gli eventi del IV sec. a.C., potrebbero essersi svolti in Sicilia secondo questa ricostruzione lo si deduce, tra l’altro, dai successivi eventi accaduti tra il 213 e il 211 a.C., quando i Romani giunti nell’isola già nel 263 a.C., riprese le ostilità con i Siculi che alla morte di Gerone II erano passati dalla parte dei Cartaginesi, ritenendo che la inarrestabile forza combattiva degli isolani fosse dovuta alla protezione che la divinità sicana, cioè Adrano, riservava loro, con rito magico ne chiusero i templi in tutta l’isola, proibendo con tale atto ai Sicani di celebrare i sacrifi. Ciò significa che la dominazione greca dell’isola non aveva scalfito, ancora dopo secoli della loro presenza sull’isola, né il culto né le ancestrali tradizioni sicane.
LE MIGRAZIONI DEI SICANI
La presenza in Europa dei tre toponimi/idronomi: il Río de Adraño in Spagna (in verità in Spagna come in Sicilia, come sopra affermato, vi erano più toponimi collegati all’Avo Adrano: monte Adranone nella Sicilia centro occidentale e rego de Adran in Spagna), la città di Adrano in Sicilia, il fiume Adrana in Germania, oltre che indurci a porre la domanda quale sia stata la sede originaria dei Sicani, per la quale rimandiamo i lettori all’articolo, I Sicani: origine e sito, miti3000.eu, potrebbe spiegare in parte, la presenza delle incisioni rupestri – datate da venti a trentacinquemila anni fa- e delle pitture delle grotte di Lascaux, nella Francia sud-occidentale, delle grotte di Altamira in Spagna, dell’Addaura in Sicilia, di Fumana nel Trentino, in Italia, come tracce lasciate da un popolo portatore di una condivisa cultura di provenienza. Parlando delle pitture rupestri e dei loro esecutori, ai quali gli studiosi attribuiscono la volontà di imprimere un carattere sacro rituale alle immagini zoomorfe e antropomorfe rappresentate, non si può fare a meno di effettuare un volo pindarico ed esaminare il significato del nome Sicano. Facendo appello alla disciplina che studia il significato dei lessemi, crediamo che l’etimo sicano possa essere un appellativo apposto ad una tribù fra le tante sparse nel territorio nord europeo, per distinguerla in base a determinate caratteristiche da altre tribù, che a loro volta assumevano appellativi i cui significati evocavano i rispettivi ruoli sociali: Siculi ovvero i mandriani, da sich se, se medesimo e kuh vacca; Ciclopi, scalpellini ovvero coloro che percuotono il suolo, la pietra, da Ki terra e Klopfen percuotere, picchiare; Cilliri ovvero costruttori di navi da kiel chiglia ecc. L’appellativo Sicano dovette dunque indicare, proseguendo con la tesi su esposta, originariamente una èlite di uomini dotati di particolari sensibilità che le avrebbero permesso di stabilire una comunicazione con la dimensione extrafisica. I sich Ahne ovvero coloro che erano della stessa essenza degli Avi, sarebbero stati ritenuti dal popolo, individui capaci di entrare in contatto, in particolare, con gli antenati, Ahne, i quali avevano la loro dimora in Hell, uno spazio non meglio definito che si trovava tra il cielo, sede degli dèi, e la terra. Per estensione, l’appellativo sich Ahne, si sarebbe trasmesso da una élite all’intero popolo, esattamente come presumiamo sia avvenuto per gli abitanti della città di Adrano ove esisteva già la casta sacerdotale degli Adraniti ancor prima che la città di Etna venisse rinominata in Adrano. I sich Ahne assumevano, di conseguenza, anche il ruolo di custodi della tradizione, erano i garanti di un ordine cosmico che non doveva mutare pena l’interruzione del ponte che univa l’aldilà con l’aldiquà. A formulare questa conclusione ci induce altresì lo stesso significato etimologico che attribuiamo al termine Sicano. L’appellativo, infatti, attraverso il pronome riflessivo sich, metterebbe in evidenza il carattere ereditario se non di consustanzialità che intercorrerebbe tra l’Avo primordiale e gli eredi.
FUGA DAI GHIACCIAI DEL NORD EUROPA
Le nostre indagini storiche riguardo ai popoli antichi, i cui risultati sono stati pubblicati in diversi libri e siti Web, giungono alla conclusione che vi sia stata una civiltà autoctona con sede nell’estremo nord Europa e, che, col sopraggiungere delle glaciazioni sia emigrata in direzione sud. Ma questo tema è stato trattato sufficientemente nell’articolo “Sumer. Gli Dei vengono dall’occidente” miti 3000.eu, per riprenderlo in questa sede.

Le tracce di una migrazione avvenuta in direzione nord-sud si ritrovano nei testi sacri dell’Avesta e dei Veda, quest’ultimi rivisitati dallo studioso indiano B.G. Tilak la cui grandiosa opera, La dimora artica dei Veda, merita di essere consultata. Per ciò che concerne i Sicani della Spagna, come si può chiaramente vedere dalla cartina geografica che riportiamo e come si può constatare attraverso le sconcertanti affinità mitologiche, toponomastiche ed onomastiche che intercorrono tra irlandesi e Siciliani (vedi l’articolo, Sicani e Celti Irlandesi), possiamo dedurre che un popolo proveniente dall’estrema terra del nord Europa, Scandinavia o Irlanda, un ramo del quale, chiamato in seguito Sicani, raggiungesse Adraño in Spagna costeggiando la penisola iberica. Nello stesso tempo, un altro ramo, via terra, attraversando il braccio di mare che separa la penisola scandinava dalla Danimarca, raggiungeva il continente. Dalla Danimarca passando per la Germania scendeva ancora più a sud, raggiungendo la Francia ove Cesare, raccogliendo la tradizione orale locale, sosteneva appunto l’avvenuto passaggio dei Germani in Gallia attraverso il fiume Reno. In Gallia, tra l’altro, Cesare nomina la tribù dei Sequani il cui nome appare come una trasformazione dialettale locale del nome Sicani. Le frequenti migrazioni univocamente avvenute fino al Medioevo, in direzione nord-sud dei popoli nord europei, lo si evince anche grazie alle campagne romane che prendevano la direzione opposta per arrestare il flusso barbarico diretto nei territori dell’impero. Tiberio recandosi nel 5 a.C. nel cuore della Germania, viene a contatto con la tribù degli Alamanni che si dichiarava discendente dei Senoni che, a loro volta, provenivano dalla Scandinavia e che ritroveremo in Gallia, prova ulteriore questa, che il focolare di queste migrazioni si trovava nell’isola scandinava al punto da far dire allo storico Giordane che i Goti erano la vagina dei popoli.
La Liguria, confinante con la Gallia, rappresentò un passaggio obbligato per effettuare la discesa verso la penisola Italica. Scendendo lungo la penisola, una parte di questo popolo primordiale si stanziava nel Lazio ove dava vita alla civiltà latina nella quale si praticava il culto di Jah-Ano ovvero dell’Avo sensitivo, (Jah significa percettivo, veloce, sensitivo) divinità che i Sicani in Sicilia avrebbero invece appellato con l’aggettivo Odhr, furioso. Nell’isola di Sicilia le condizioni erano tali che i Sicani avrebbero lasciato una impronta destinata ad essere più profonda che altrove. Giunti nell’isola, constatata la particolare forma triangolare della stessa, forma che richiamava un simbolismo d’ordine religioso a loro familiare, la chiamarono Trinacria, toponimo il cui significato possiamo liberamente tradurre con “le tre forze dell’Avo” in quanto formato dall’unione dei lessemi tri con il significato di tre; Ano, avo e Kr forza , punto di rottura, potenza. I Sicani attribuirono la forma triangolare dell’isola ad un disegno divino in quanto essa, con quella forma simbolica, rappresentava di per sé la manifestazione del divino e la volontà da parte dell’Avo, che essi l’abitassero. Nel significato del nome Trinacria è possibile cogliere un significato ulteriore, grazie al quale gli eredi dell’Avo primordiale accampavano un diritto di ordine ereditario. Pertanto quella terra fu chiamata sicania. Quest’ultimo, per millenni convisse con quello di Trinacria. I Sicani giunti nell’isola plasmarono il territorio con la loro cultura di provenienza: i nomi dei monti, dei fiumi, delle prime fondazioni di città rimasero sicani; con i nomi venivano veicolati concetti profondi, il più delle volte collegati ad una visione del cosmo in cui tutto era connesso. I Sicani ritenevano possibile che si potesse stabilire un passaggio tra il mondo visibile e quello invisibile: i luoghi della terra non erano omogenei, ve ne erano di quelli in cui, grazie alle loro caratteristiche, alle forze promanate, era possibile stabilire un contatto con le potenze che abitavano lo spazio ultraterreno l’Hell. I monti Peloritani, per fare un esempio tra i tanti, per la loro caratteristica, rappresentavano per i Sicani uno di questi luoghi, lo si deduce dal significato etimologico del nome; infatti l’etimo risulta formato dall’accostamento dei lessemi Bel, Signore; or ascolto ed eitan evocare, pregare, chiamare traducibile liberamente con: il luogo in cui si può stabilire un contatto con il divino. Ancora al tempo di Cicerone, questi poteva fare riferimento, ad un dio autoctono chiamato Urio, il cui santuario si trovava a Siracusa, oggetto di pellegrinaggio. Nell’isola un importante santuario dedicato ad una dea veniva edificato dal sicano Erik (Erice) che appellava la divinità quale sua divina madre. Il monte, e poi la città fondata dal sicano Erik, da lui avrebbero preso il nome: Erice. Perfino i romani s’inchinarono al culto ericino ritenendolo il più antico dedicato ad Afrodite, come sosteneva Cicerone nelle verrine e confermato da T. Livio nella Storia di Roma. Quasi contemporaneo di Erik o Erice, un grande principe sicano fu il poco indagato Cocalo. La fama, il prestigio e la magnanimità del principe che governava sul territorio agrigentino, solcarono le acque di Sicilia per approdare sulle coste di Creta, al punto da muovere gli appetiti di conquista del re di questa piccola, ma potente isola, Minosse. Ancora nel VI sec. a. C. alcuni principi sicani di Sicilia utilizzavano l’etnico che tradisce le loro nordiche origini, , è il caso di Teuto principe di Innessa. Questa città, successivamente rinominata in Etna, come afferma Diodoro siculo e poi in Adrano come emerge dalle nostre ricerche (vedi l’articolo “La terra dell’Avo. Il santuario di Adrano”) si trovava alle falde dell’Etna. Il nome Teuto riconduce a quel popolo scandinavo, i Teutoni, che Pitea, nel IV secolo a. C. incontrò nel corso del viaggio intrapreso via mare che dallo stretto di Gibilterra, costeggiando la Spagna e la Gallia, lo condusse fino alle coste della penisola scandinava nel mar del Nord. Anche grazie alla presenza di Senone di Mineo citato da Cicerone nelle verrine per il proprio elevato status sociale, abbiamo modo, attraverso l’etnico che lo contraddistingue, di confermare l’origine nordica del vetusto popolo siciliano. Infatti, appare evidente che il nostro Senone abitante di Mineo, città che diede i natali al principe Ducezio (in Gallia Cesare menziona una città che si chiama Ducezia), presso la quale si trovava il santuario dedicato agli dèi Palici figli dell’Avo Adrano, condivida le origini di quel più illustre personaggio proveniente dalla tribù gallica dei Senoni, ci riferiamo a quel Brenno che passò alle cronache con il soprannome di incendiario, dal verbo tedesco brennen incendiare. Ed in fine come far passare sotto silenzio l’antico nome della Spagna, appartenuto, seppur con trascurabile modifica, all’Irlanda? Ossia Iberia? -i Romani, seguendo le consuetudini del luogo, chiamavano l’Irlanda sia Hibernia che Iperborea-. Tutto si collega se, poi, vi si aggiunge quanto riportato dallo storico di Agira Diodoro[1] il quale, nel libro II,47 della Biblioteca Storica accenna al culto dell’Apollo iperboreo greco. Il culto greco trae origine infatti, a nostro parere, dall’Irlanda, appunto chiamata iperborea. Il rapporto tra l’Irlanda e la Grecia rimase costante per molto tempo se Diodoro fa cenno ad una ambasceria proveniente dal popolo degli Ari inviata a Delo, città della Grecia in cui il culto dell’iperboreo Apollo era tenuto in alto conto. Nell’Odissea, nel libro che Omero dedica ai Feaci, popolo che in un nostro articolo abbiamo collocato a Siracusa, si fa riferimento ad una terra chiamata Iperia. È ipotizzabile che anche in questa occasione, se teniamo conto della mutazione consonantica espressa dalla legge di Grimm, che avrebbe trasformato la b in p, il poeta cieco faccia riferimento all’isola iperborea. L’etnico di Celtiberi apposto -anche se in un periodo molto posteriore rispetto a quello dell’epoca sicana – agli abitatori dell’Hiberia, la Spagna, sarebbe comunque indicativo di un percorso avviato in epoche remote, continuato per millenni e conclusosi in epoca medievale, ancora una volta con la migrazione scandinava dei Goti del V secolo e dei Normanni nell’XI sec.
CARATTERISTICHE SICANE DELL’HIBERIA E CONSANGUINEITA’ CON I CELTI.
Purtroppo della civiltà sicana, in Spagna non rimangono molte tracce; ciò rende difficile l’indagine. Tuttavia potremmo tentare una ricostruzione culturale che colleghi la Spagna sicana con i Sicani del Lazio e della Sicilia grazie al metodo della comparazione. Uno degli anelli di congiunzione che collega la Spagna con la cultura europea sicana la si può rintracciare grazie al nome apposto, con leggere varianti linguistiche determinate dai dialetti locali, ora ad una tribù ora ad un ordine sacerdotale, sono questi i Salii. La presenza dei Salii, il cui nome facciamo derivare da una lingua protogermanica (vedasi l’articolo, Jam akaram: la lingua dei Sicani,) e che, secondo il nostro metodo interpretativo ormai noto ai lettori, risulta formato dall’unione dei lessemi sah che significa conoscere, vedere nella sua accezione metafisica ed Hell indicante lo spazio, un luogo fra cielo e terra ove albergano libere forze d’ordine extrafisico, è attestata in Olanda nella regione detta Salland, in Inghilterra nella variante di Siluri, tribù citata dallo storico Tacito, la quale, secondo lo storico proviene dalla Spagna; nella costa tra la Gallia e la Liguria ove viene citata da Strabone (Geografia lib. IV) con il nome di Salui e nell’Italia centrale, nel Lazio. A Roma i Salii rappresentavano un ordine sacerdotale istituito da Numa Pompilio, il secondo re di Roma che asseriva di essere in contatto con la ninfa Egeria sua consigliera. Numa, il mitico re-sacerdote, proveniva da una tribù il cui nome sembra mostrare affinità semantiche con quella dei sah–hell cioè dei Salii, ci riferiamo a quella dei Sabini, nome che liberamente interpretato significa coloro che traggono da dentro (l’ispirazione ?) la conoscenza. Infatti il nome Sabini risulta composto dall’unione dei lessemi sah vedere, nell’accezione di conoscere, ab trarre, porre fuori e inna dentro, interiore. Sulle origini nord europee di Roma e il rito druidico svolto in occasione della sua fondazione dal re-sacerdote Romolo, abbiamo già detto sufficientemente nell’articolo dal titolo l’arte regia di Ramnes\Romolo e la fondazione di Roma, per ritornarvi in questa sede. Al contrario di quanto dedotto da Tacito nel suo trattato dedicato al suocero Agrippa, a proposito del passaggio dei Salii dalla Spagna in Inghilterra, a noi sembra più verosimile l’inverso, cioè che dall’Inghilterra, se non dalla Scozia ove era fortemente radicata la tradizione druidica, i Salii fossero passati sul continente per dirigersi a sud, in occidente e in oriente[3].
Non ci sembra qui fuori luogo approfondire il ruolo che fu affidato a questa potente casta sacerdotale nella città destinata a governare il mondo allora conosciuto. I Salii romani erano in numero di dodici ed avevano il compito di custodire l’Ancile, lo scudo caduto dal cielo. All’Ancile era collegato, secondo un antico oracolo, il destino dell’Urbe. Pertanto Numa ne fece realizzare altri undici identici all’originale al fine di confondere chi avesse voluto minare, distruggendo l’Ancile, il compito a cui l’Urbe era destinata dal Fato. Infatti era opinione comune, riportata da Plinio il vecchio, che la città fosse sorta per volontà degli dèi onde mettere ordine, suo tramite, nel mondo. Il custode dell’Ancile era denominato Flamine Diale; il lessema Dell da cui deriva Diale, in lingua germanica significa appunto celare, nascondere. Il Flamine Diale aveva dunque il compito di tener celato il vero Ancilia. I sacerdoti Salii avevano il compito altresì di chiudere ed aprire la porta del tempio di Jahno (Giano bifronte) a seconda che si era in guerra o in pace. Che l’ordine sacerdotale dei Salii potesse essere stato istituito da Numa, come è riportato da T. Livio, è possibile, ma bisogna tener conto che i riti da essi espletati esistevano nel Lazio ancor prima della fondazione di Roma. Ne è testimone l’antiquario Virgilio il quale, nel suo poema l’Eneide, in cui si nasconde fra le righe del racconto una lettura diversa da quella palesemente comunicata (vedi il nostro saggio, Dalla Scania alla S(i)cania, gratuitamente fruibile), precisa che l’apertura della porta del tempio di Jano era prerogativa del re Latino. In lingua germanica porta si dice Tor è Tor era un dio germanico equiparabile al dio latino Marte. Marte, secondo la tradizione romana, era il dio della guerra, padre di Romolo e colui che aveva lasciato cadere dal cielo l’Ancilia, cioè lo scudo. L’atto del dio corrispondeva dunque ad una iniziazione guerriera, alla quale l’intero popolo romano era stato sottoposto. Ora, si dà il caso che il rito della chiusura e apertura della porta era condiviso dai Sicani del Lazio con quelli della Sicilia. Gli storici che fanno menzione del rito siciliano dell’apertura e chiusura delle porte del tempio del dio Adrano, sono Plutarco, inconsapevolmente, nella vita di Timoleonte e Diodoro indirettamente, affermando che furono proprio i Romani, tra il 213 e il 211 a. C., probabilmente avendo intuito l’affinità tra il dio Adrano a Jahno, a chiudere forzosamente la porta del tempio del dio sicano, affinché non potesse nuocere col suo “furore” (odhr) alle legioni, erigendovi un muro tutto attorno.

Cerchiamo ora di rintracciare le tradizioni mitiche degli Spagnoli partendo da quanto viene riferito da Strabone nel suo trattato di geografia. Il geografo, preoccupato soltanto dell’aspetto geografico del territorio spagnolo, citando lo storico Eforo dimostra di non avere affatto la curiosità di un Plutarco affetto da una inestinguibile sete di conoscenza o un Tucidide che non tralasciava, pur non trascurando la sua missione di storico, di comprendere le origini del popolo siciliano. Pertanto egli non comprende il significato religioso e rituale di cui adesso diremo basandoci sulle sue stesse descrizioni e dichiarazioni. Strabone nel lib.III,2,11 della Geografia, afferma che Polibio, lo storico al seguito degli Scipioni che scrisse una storia di Roma, riconoscesse agli Iberi una consanguineità con i Celti. A questa esplicita affermazione, possiamo aggiungere quanto il geografo sostiene nello stesso trattato di geografia nel libro III, 1,4 e cioè che lo storico Eforo si sarebbe sbagliato nell’affermare che nello stretto di Gibilterra vi fosse un tempio o altare dedicato ad Ercole in quanto Strabone afferma che in quel luogo era constatabile soltanto la presenza di pietre disposte a tre o quattro in più punti. È evidente che Strabone parlando distrattamente di pietre si stesse riferendo a quei dolmen e megaliti che numerosi ritroviamo in Europa, senza che egli ne comprendesse il significato sacro che questi templi rivestivano per le popolazioni nord europee, e che quindi la consanguineità affermata da Polibio tra Celti e Iberi, nulla suggerisse al disattento geografo. La superficialità del geografo risulta ancor più stupefacente subito dopo, quando egli afferma che presso quelle pietre il popolo era d’uso farvi delle libagioni e che era proibito andarvi di notte, poiché proprio a quell’ora, il luogo sarebbe stato occupato dagli dèi: “ Chi lo vuole visitare” afferma il geografo, “deve pernottare nel villaggio più vicino e recarvisi di giorno portandosi l’acqua che in quel luogo scarseggia”. È evidente che Strabone stia descrivendo una pratica rituale familiare agli Iberici ,ma che egli ignora. Infatti, nei riti celtici, l’acqua assume un ruolo rituale fondamentale, come si deduce dalla presenza di numerose vasche in Gallia, vasche che erano costruite dai Druidi e tra le quali figura quella di Bibrachte che è soltanto la più conosciuta. Continuando ancora con le preziose informazioni sui tramonti, le albe e i movimenti del sole, dai tratti particolari, che si manifestano in quel luogo, su cui Strabone si sofferma e di cui egli ignora il palese significato simbolico, appare evidente che nel luogo indicato dal geografo, nei pressi delle colonne d’Ercole, vi si svolgesse il rito dei solstizi e degli equinozi.
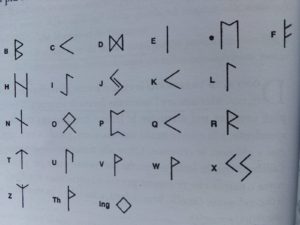
Pertanto, i dolmen che per Strabone sarebbero inutili pietre, mettono in relazione, a nostro avviso, la Spagna con la cultura celtica e la stessa vicina Sicilia. Infatti, l’isola è cosparsa di dolmen e rocce forate la cui presenza era funzionale al rito legato ai solstizi e agli equinozi, come abbiamo spiegato in altre occasioni. Nella regione dei Gaditiani, nella città di Asta, la più importante della regione secondo le affermazioni di Strabone, veniva praticata una consuetudine a noi familiare, in quanto descritta da Cesare per ciò che concerne il popolo dei Carnuti della Gallia ed in uso a Upsala in Svezia presso la prateria di More, una assemblea popolare. Continuando ad elencare le affinità culturali tra Celti ed Iberi che Strabone mette inconsapevolmente a nostra disposizione, a noi non sfugge il suo riferimento a Polibio il quale, a proposito del fiume Anas, afferma che esso nasce dalla Regione dei Celtiberi e che il nome apposto al fiume sia addebita ile ai Celtiberi che parlavano una lingua germanica, il celtico. Il lettore si ricorderà che Ano significa nella lingua germanica avo, antenato, pertanto Anas dovrebbe corrispondere al sostantivo femminile –Presso i Persiani la divinità fluviale si chiamava Anaita; I Greci chiamavano la regina Anassa mentre gli Ittiti la appellavano tawananna alludendo alla regina madre; il primo re ittita si chiamava invece, Anittas ovvero colui che evoca, o è egli stesso, la voce dell’Avo, da An-iti-Hass-. Secondo le asserzioni di Strabone, Il popolo che viveva presso il fiume Anas, dunque i Celtiberi, era il più colto e, conservava, a detta del geografo, documenti scritti della propria storia antica di sei mila anni. Ora, parlando della scrittura degli Iberi, non può passare inosservata la similitudine dei caratteri di questa, nelle epigrafi rinvenute e fatte risalire dagli studiosi al 400 a.C., con i caratteri utilizzati nella scrittura barriforme celtica definita runica.
Ad majora.
[1] Ur-ANO; Jah-ANO; mn-ANO; ANO; odhr-ANO sono i differenti modi con cui l’Avo comune, l’Ano, veniva appellato rispettivamente da Greci, Latini, Germani, Sumeri e Sicani di Sicilia significando rispettivamente: l’Avo primordiale; l’Avo intuitivo; l’avo mentale o il potere della mente dell’Avo; l’Avo; l’Avo furioso o divino. Lo stesso termine Sicano o sich Ano significa l’avo in sé, cioè il pronome personale sich, sé, sé stesso, indica il concetto di consustanzialità tra l’Avo, l’Ano e l’erede cioè il Sicano.
[2]( …) Ecateo e alcuni altri affermano che nelle regioni poste al di là del paese dei Celti c’è un’isola non più piccola della Sicilia; essa si troverebbe sotto le Orse e sarebbe abitata dagli Iperborei, così detti perché‚ si trovano al di là del vento di Borea. Quest’isola sarebbe fertile e produrrebbe ogni tipo di frutto; inoltre avrebbe un clima eccezionalmente temperato, cosicché‚ produrrebbe due raccolti all’anno. Raccontano che in essa sia nata Leto: e per questo Apollo vi sarebbe onorato più degli altri dei; i suoi abitanti sarebbero anzi un po’ come dei sacerdoti di Apollo, poiché‚ a questo dio si inneggia da parte loro ogni giorno con canti continui e gli si tributano onori eccezionali. Sull’isola ci sarebbe poi uno splendido recinto di Apollo, e un grande tempio adorno di molte offerte, di forma sferica. Inoltre, ci sarebbe anche una città sacra a questo dio, e dei suoi abitanti la maggior parte sarebbe costituita da suonatori di cetra. – Diodoro siculo Biblioteca storica II,4.[3] Tacito, come si evince nella vita di Agricola, crede che la tribù dei Siluri in Britannia, potesse essere arrivata dalla Spagna a motivo delle simili caratteristiche somatiche. Non è da escludere, piuttosto, che l’antichissima migrazione dei Salii o Siluri, partita dalla Scozia o comunque dal nord, giunta in Spagna, avesse mantenuto con la madre patria dei rapporti filiali, un cordone ombelicale che non si era mai del tutto reciso e che dunque, nel corso dei secoli, se non millenni, i matrimoni misti avvenuti tra cittadini della madrepatria Britannia e la colonia spagnola, avesse portato ad un rimescolamento del corredo genetico. Testimonianza dell’abitudine di mantenere rapporti solidi tra la patria e le colonie è testimoniata da Diodoro siculo nel libro II,42 in cui cita il gemellaggio tra la città greca di Delo e gli Iperborei a motivo dell’antenato comune Apollo. Un caso italiano simile era il gemellaggio intercorso tra la sicana cittadina siciliana di Centuripe e la cittadina sicana del Lazio Lanuvio (Vedi Centuripe, l’antica stirpe).
Iniziazioni Sicane nella Valle delle Muse sul fiume Simeto.
Tutte le religioni del mondo furono portatrici di una verità comunicabile soltanto a coloro che erano in grado di sostenerla. Ai semplici di spirito venivano svelate conoscenze adeguate al loro livello di comprensione. Recitava, infatti, un antico adagio Veda che il saggio non deve scandalizzare il semplice con il proprio sapere. Era, la religione, una scuola dello spirito e, in quanto scuola, avrebbe dovuto seguire delle tappe graduali di comunicazione della conoscenza.
www.adranoantica.it
I Sicani in Adrano: Il Pagus e il territorio.
Fu detto che il cercare rappresenta una esigenza dello spirito, un modo di essere, tipico di chi non si accontenta di fermarsi alla superficie delle apparenze. Facendo nostre tali affermazioni, tuttavia, bisogna riconoscere che il ricercatore corre il rischio, a volte, di rimanere incastrato nelle fitte maglie di una rete di tesi delle quali si è pregiudizievolmente innamorato. Vorremmo, pertanto, in rispetto alle Muse, gelose custodi della verità, mettere in guardia i nostri lettori invitandoli a verificare quanto di volta in volta affermeremo e, là dove siano in grado di farlo, correggerci fornendo il proprio contributo in questo sito.
PREMESSA
Le ricerche da noi condotte nel territorio di Adrano, non sono motivate esclusivamente dall’orgoglio di appartenenza che, tuttavia, le alimenta, ma da una domanda che ricorre in noi con ritmica frequenza: perché? Perché i nostri Avi scelsero il territorio adranita per erigervi la dimora del dio nazionale sicano, Adrano?
LA DIMENSIONE RELIGIOSA LEGATA AL TERRITORIO.

Per rispondere alla domanda sopra posta, dobbiamo entrare in empatia con il mondo degli Avi, un mondo complesso che rappresenta il risultato di una sommatoria di elementi che interagivano tra di loro. La componente paesaggistica, le forze extrafisiche promanate dal luogo, avrà avuto certamente una influenza non indifferente nel plasmare la cultura dei Sicani, la loro filosofia, la loro visione del mondo. L’uomo di quel tempo si sentiva parte del mondo, della natura. Gli Dei si manifestavano in ogni cosa: nello splendore di una gioiosa alba o nel malinconico barlume del crepuscolo; l’uomo si sentiva in armonia col cosmo ed egli stesso si percepiva come un microcosmo parte del macrocosmo; atomo di quell’universo inteso come un corpo unico.

Il mondo esteriore riflette infatti il mondo interiore; l’uomo riflette il cosmo; la struttura del l’atomo riflette quella del sistema solare. Di conseguenza, nel tentativo di comprendere il loro mondo interiore, riflesso di quello esteriore, in cui vigevano parametri di valutazione diversi dai nostri, ricostruimmo scientificamente, consultando le fonti antiche, interessando la professionalità di geologi, archeologi, studiosi delle più diverse discipline scientifiche, maestranze locali, un plastico rigorosamente in scala 1:1.000, fruibile dal pubblico, che riproduce parte del territorio adranita con le ampie cascate di acqua ancora scroscianti agli inizi del XX secolo, oggi scomparse, fiumi disseccati, fitti boschi di querce, betulle e leccio popolati da cervi e cinghiali, come risulta dai reperti di ossa di animali neolitici ritrovati in loco, che cedettero la fertile zolla ai rigogliosi mandorleti impiantati nell’ ‘800 i quali, come afferma Cesare Abba nel suo diario di guerra diventato un libro di narrativa adottato dalle scuole negli anni ’60 , “da Quarto al Volturno” , con i loro nutrienti frutti aiutarono i Piemontesi a superare la carestia sopraggiunta nel XIX secolo. Dalla parziale ricostruzione del mondo abitato dai nostri Avi, dei suoi aspetti visibili, di quelli percepibili e intuibili (l’intuizione sopperisce alla assenza della storia scritta), arrivammo alla conclusione che gli abitanti della Sicilia tutta, allora chiamata Sicania, fino alla fine del III, inizi del II millennio a.C., vivessero in armonia con la natura, con il mondo, non interferendo invasivamente in esso attraverso la costruzione di strutture imponenti e come diremmo oggi, di impatto ambientale; la natura forniva loro cattedrali naturali. La Grecia che per vicinanza geografica maggiormente risentiva dell’influenza culturale dei popoli orientali, costruttori di ziggurat, piramidi, giardini pensili, edificarono tuttavia il primo tempio di pietra a Delfi dedicato ad Apollo soltanto nel XVII sec. a. C., mentre nel nord e nell’Europa centrale i Romani, ancora nel I sec. a.C. al loro arrivo non vi trovarono che pagliericci di canne nonostante quei popoli fossero abili costruttori di edifici megalitici, come dimostra la numerosa presenza di dolmen e menhir.

Ma l’utilizzo della pietra rientrava nella visione religiosa del cosmo che essi avevano maturato in seguito alla osservazione del creato. Striderebbe, secondo il superficiale giudizio dell’osservatore moderno, la presenza di quelle fragili capanne con la mole delle conoscenze posseduta da quei popoli. Questi erano in grado di riprodurre su dei manufatti le costellazioni che riempivano la nera volta celeste, come dimostra il ritrovamento del disco di Nebra realizzato, secondo le opinioni degli accademici, nella “barbarica” Germania dell’età del bronzo, e come riferirà in seguito Cesare a proposito delle conoscenze dei Druidi e il lunghissimo apprendistato dei neofiti. La pietra, utilizzata grezza per la messa in opera dei megaliti, veniva accostata al concetto di eternità, di durezza, di potenza ed immutabilita’. Come sopra affermato, in Grecia, a Delfi, nel XVII sec. a. C. veniva costruito il primo tempio in pietra dedicato al dio della luce Apollo. Condividendo le intuizioni del Bacofen circa l’avvicendamento del matriarcato col patriarcato che verrebbero ad esercitarsi nella gestione del consorzio umano, vorremmo aggiungere una nostra personale intuizione sull’innovazione introdotta in Grecia nel modo di costruire il tempio di Apollo: riteniamo possibile che la costruzione di questo primo tempio in pietra, porti in sé un simbolismo fondato sull’affermazione del patriarcato in una società pregreca che fino a quel momento era retta sul concetto di matriarcato. La deduzione esposta prende corpo se si constata che il tempio del dio Apollo viene eretto, secondo il mito tramandato e confermato dall’archeologia, sulle fondamenta della dea sconfitta. Il tempio viene costruito in pietra in quanto la pietra veicola l’idea della durezza, della immutabilita’, della stabilità e incorruttibilita’, in opposizione al matriarcato a cui corrisponde il simbolismo dell’acqua e, dunque, della fluidità, della instabilità, del mutamento. Ma per chi fosse interessato a questo specifico argomento d’ordine metafisico, consigliamo la lettura della magistrale opera dell’autore sopra citato: “Il matriarcato”, ed. Brancato. Analizzando il procedere degli eventi nei secoli successivi, si constata che in Grecia vengono travisati i concetti veicolati dall’utilizzo simbolico della pietra sopra affermati. Lo si evince dalla ricercata raffinatezza architettonica ed estetica con cui vengono costruiti i templi. Non più la pietra grezza, ma lucide colonne marmoree sostengono la volta. I templi diventano sempre più imponenti, più lussuosi; essi saranno concepiti quali simbolo di affermazione di singoli individui, nel caso in cui ad edificarli siano dei tiranni, o dello stato, lungi dal rappresentare l’epifania del divino. Da questa surrogata visione del mondo dei padri, ecco giungere, un millennio dopo la costruzione del tempio del luminoso Apollo, l’inizio della fine dell’equilibrio cosmico con il ritorno del matriarcato. Questo è caratterizzato da una particolare attenzione, nella costruzione dell’edificio, all’estetica e all’effimero che valse ai greci, da parte dei nuovi “barbari”, i romani, con i quali gli effeminati Greci vennero a contatto, l’appellativo dispregiativo di “graecula”, ebeti contemplatori di statue che avevano perso la virilità di un tempo. Nel contempo, in tutto l’occidente, l’uomo iniziava ad esercitare il proprio dominio sul mondo che lo circondava. Egli, imponendosi sulla natura recideva consapevolmente il cordone ombelicale che lo legava ad essa.
IN SICILIA
Nell’isola proprietà dell’Avo primordiale Adrano, l’armonia tra uomo e natura dovette avere una vita assai più lunga che altrove, e Virgilio, nel comporre l’ Eneide, si sentì in obbligo di inserire nel suo poema un riferimento agli dei Palici, figli di Adrano, la cui ara si trovava, ed ancor oggi è lì a sfidare il tempo, sul greto del fiume Simeto, circondata da boschi popolati da Ninfe, nelle contrade dell’attuale e pur vetusta città di Adrano. Il poeta mantovano dimostra, con i suoi riferimenti siciliani, di conoscere bene la Sicilia e i suoi miti, del resto, nel comporre le bucoliche, il poeta aveva avuto nel siciliano Eraclito il suo riferimento stilistico. A nostra volta, grazie ad una ricostruzione paesaggistica, ottenuta con il contributo di diverse discipline scientifiche, ci sentiamo di poter affermare che l’isola, ancora fino al periodo in cui il poeta la decantava, trasudasse inalterata la sua primordiale genuinità.
Come di consuetudine condivideremo in questo articolo con i nostri lettori, alcune deduzioni, per quanto esse possano apparire poco accademiche, sottoponendole al loro giudizio, il solo che ci sta a cuore, non senza aver citato le fonti ispiratrici che ci hanno animato.
IL PRIMO CONTATTO CON LA CULTURA NORDICA

I commentari dello storico romano Tacito e quelli del divo Cesare, rappresentano per noi due fonti preziose e attendibili per ricostruire, per quanto sia possibile, le abitudini dei nostri Avi Sicani, la loro cultura, il senso spiccato della loro libertà individuale e collettiva. I due Romani sopra citati, pur descrivendo le caratteristiche dei popoli germanici, ci aiuteranno, come vedremo grazie all’ausilio delle discipline comparate (vedasi l’articolo: ‘I sicani: le origini e il sito‘ – miti3000. eu), a ricostruire quell’ epoca velata, della cultura sicana in Sicilia. I ritrovamenti archeologici in Sicilia, nel territorio adranita in particolare, risultano essere assai chiarificatori per ciò che concerne la nostra sostenuta affinità culturale tra la civiltà nord europea e quella siciliana della prima ora. Fra i reperti rinvenuti ad Adrano spiccano quelli che riproducono la simbologia delle spirali, delle ruote del sole, delle vasche sacre d’acqua che in Europa erano gestite dai druidi; appaiono nel territorio adranita, più che altrove in Sicilia, teonimi, toponimi, una diffusa onomastica, una oronimia ed epigrafi riconducibili alla lingua comune nordica (vedi l’articolo – la lingua dei Sicani – miti3000. eu). In altri luoghi della Sicilia abbonda il ritrovamento di svastiche disegnate su ceramica, presenza non ancora attestata, però, nel territorio adranita.
Quanto affermeremo qui di seguito troverà un senso per coloro che hanno seguito le nostre ricerche, attraverso le quali si è resa possibile e comprensibile la tesi delle origini comuni tra i Sicani e i popoli del nord Europa; tesi supportate, come è giusto che si esiga dal ricercatore, da prove oggettive. Molte di queste prove, poiché sono state esposte nei numerosi saggi e articoli apparsi un po ovunque, ritenendo tedioso per il lettore riproporle in questa sede, le ometteremo. I Sicani, dunque, facevano parte della grande famiglia degli Indoeuropei, di questi ne costituivano un ramo staccatosi durante il periodo delle grandi migrazioni post glaciali. I cambiamenti climatici sopraggiunti nelle varie epoche, l’ultima circa dodicimila anni fa, che rendevano sempre più invivibile la terra di origine, sono descritti nel testo sacro iraniano l’Avesta, e, indirettamente, utilizzando un linguaggio criptato da metafore, esposti nel Veda, testo sacro del popolo indiano. In quest’ultimo testo sarebbero contenute, secondo le dottissime conclusioni dello studioso indù B. G. Tilak le prove delle su dette migrazioni. Tilak, suffragata da prove testuali, nel suo saggio “la dimora artica dei Veda” propone la tesi secondo la quale il popolo veda provenisse dal circolo polare artico e che ivi abitasse prima dei cambiamenti climatici sopravvenuti. Uno degli effetti delle antiche migrazioni avvenute in univoche direzioni: da nord a sud, consisteva nel fatto che i popoli emigrati condividessero, ancora per un lungo periodo di tempo successivo alle migrazioni, una comune weltanshauung. Questa condivisione veniva tramandata alle generazioni successive non soltanto attraverso una tradizione orale, ma mettendo in atto regole di vita e consuetudini rimaste immutate per millenni.
LE CITTÀ
Una di queste consuetudini consisteva, per esempio, nell’ abitare in villaggi a contenuta densità democrafica, non oltre le duemila unità. I villaggi erano formati da famiglie che avevano contratto vincoli di parentela attraverso i matrimoni. Il vincolo parentelare rendeva monolitico il rapporto tra i cittadini del villaggio. Ci spieghiamo perciò, grazie a questa consuetudine di vita, il ritrovamento nel territorio adranita di villaggi formati da capanne, vicinissimi tra loro, fatti risalire dagli studiosi al IV, III millennio a. C. I villaggi catalogati dagli archeologi erano sparsi in almeno sette contrade del territorio adranita. Ogni villaggio distava dall’altro non più di due chilometri. Gli agglomerati abitativi, nonostante il basso numero di abitanti che li occupavano, coprivano però una area molto vasta; ciò era possibile in quanto tra una capanna e l’altra esisteva uno spazio franco.
La formulazione del l’ipotesi che ogni villaggio fosse abitato da un numero inferiore ai due mila individui, trae fondamento dal resoconto che Cesare fornisce nella sua guerra gallica a proposito del re Ariovisto.
Avendo portato, come sopra affermato, sufficienti prove negli articoli precedentemente pubblicati circa la consanguineita’ tra i Galli, i Germani, i Sicani, abbiamo applicato a questi ultimi le caratteristiche che Cesare osservò sui Germani. Il romano affermava con attendibilità, ottenendo le sue informazioni dall’Eduo Diviziaco, suo alleato e druida, che il re Ariovisto aveva al suo seguito sette popoli, in tutto centoventimila teste tra uomini donne e bambini, convergenti da cento pagi. Dunque, facendo una media aritmetica se ne deduce che ogni pagus era abitato da circa mille e duecento individui. Le abitudini demografiche osservate da Cesare nei pagi, verranno confermate ancora cinque secoli dopo che il romano assurgesse a divo, allorché Genserico re dei Vandali, popolo proveniente dalla Scandinavia, strappato I territori del nord Africa alla molle civiltà Bizantina, insediando gli ottantamila guerrieri che lo seguivano, ebbe cura di distribuirli nel territorio tunisino secondo le ataviche abitudini della cultura di provenienza: a gruppi di mille. Ad ogni gruppo venne assegnato un territorio misurato con la funicella. Tralasceremo in questa sede di esaminare l’appellativo apposto al re dei germani Teodorico, “THIUTA-REIKS”: padre del popolo, appellativo che lo accomunerebbe, secondo il risultato dei nostri studi, al re di Innessa Teuto, lessema, quest’ultimo, che si trova inserito nella celeberrima epigrafe incisa nella stele di calcare ritrovata in contrada Mendolito, nei pressi di Adrano. Quattrocento anni dopo l’epoca di Genserico e Teodorico, i barbari germanici che assumeranno l’attributo di Vichinghi , colonizzando l’Islanda distribuiranno nel territorio islandese gruppi umani formati ancora una volta, da mille individui.

Dovremmo dedurre, considerando che i Sicani di Adrano, come si evince dai reperti archeologici recuperati, popolavano almeno sette, otto contrade e cioè, Adrano centro, Naviccia, Pulica, Fogliuta, Fontanazza, Burrello, Tabana, che il numero totale degli abitanti dell’ampio territorio adranita fosse di oltre diecimila teste, una popolazione di tutto rispetto per l’epoca.
IL PAGUS.
La struttura del villaggio non ancora fortificato dalla presenza di mura di cinta, costituito da capanne in legno con tetti di paglia distanti l’una dall’altra una decina di metri, dovette conservarsi per un lunghissimo periodo di tempo in Sicilia poiché non vi era motivo di temere attacchi ostili da parte di popoli stranieri, dal momento che i rapporti tra i villaggi erano di buon vicinato, anzi, parentali. Il massimo degli incidenti che avrebbero potuto verificarsi tra i pagi, potevano ridursi a qualche screzio individuale felicemente risolvibile dall’intervento degli anziani (probabilmente a gestire l’ordine pubblico era una casta sacerdotale sul modello druidico dei consanguinei Celti. Per approfondimenti vedi: “Senone di Mene, I druidi in Sicilia – miti3000. eu), garanti dell’ordine costituito. Le mura, poligonali, ciclopiche o megalitiche, che possiamo ancora in parte ammirare ad Adrano, potrebbero essere state edificate intorno ai primi secoli del II millennio a.C. e non per fungere da fortificazione per il villaggio, realizzato con modeste capanne, bensì al fine di creare un recinto sacro che circoscrivesse il tempio carico delle forze mistiche dell’Avo furioso (questo significa il teonimo Adrano, nome composto dall’unione dei lessemi odhr, furioso e Ano antenato, avo). Affinché i nostri lettori abbiano un’idea di quanto affermiamo, avvalendoci delle discipline comparate, citeremo lo storico latino Tacito, il quale così descrive l’analogo modus viventi dei Germani: “Si sa che i popoli dei Germani non abitano nelle città e non sopportano neppure abitazioni contigue: vivono isolati, separati, laddove siano piaciuti loro una sorgente, un campo, un bosco, (…) ognuno circonda la propria casa di uno spazio libero (…) non impiegano neppure pietre da costruzioni né tegole, per qualunque scopo si servono di tronchi grezzi (…) “. Le consuetudini che ponevano i Germani in una perfetta simbiosi con la natura, descritte dallo storico latino, si sarebbero certamente conservate ancora a lungo se il concilio Namnetense del 890 non avesse decretato la distruzione delle immense foreste di querce nelle quali i popoli del nord Europa si recavano per interagire con gli alberi secolari. Fu quello, il disastro ambientale più immane dei boschi d’Europa. Per “intuire” quanto affermato in questo breve articolo intorno alla visione del mondo e il rapporto con esso che avevano i Sicani, si visitino le acropoli dei villaggi siciliani di Cerami, Assoro, Gagliano Castelferrato, Nissoria Nicosia … luoghi che trasudano intatte ancor oggi le mistiche forze primordiali.
SEQUANI E SICANI.
L’affinità tra i due popoli, il primo stanziale in Gallia, il secondo in Sicilia, come vedremo oltre, non è dovuta soltanto all’assonanza del nome che li contraddistingue.
Il divo Giulio si recò in Gallia su invito del giovane druida eduo Doviziaco, minacciato dalle armi dei vicini Sequani. I Sequani, ricorrono a loro volta all’aiuto fornito dai consanguinei Germani di Ariovisto. Cesare giunto sul Reno, prima di penetrate in terra straniera invia in avanscoperta degli esploratori, lo scopo aveva come fine quello di indagare sugli avversari, popolo fino a quel momento a loro sconosciuto. Gli esploratori ritornati dal generale, ancora tremanti sulle ginocchia, raccontarono che si sarebbero ritrovati a incrociare la daga con uomini di mostruosa statura; “basta che vi guardino e siete presi dalla paura” affermavano, e continuando, “nessuno è stato capace di resistere davanti a loro”. Ma Cesare, da vero Romano, non era uomo da lasciarsi impressionare; egli aveva dalla sua la disciplina, l’ordine e la strategia bellica, doti grazie alle quali pieghera’ le ginocchia non solo di quei giganti, ma di tutti i popoli che avranno la ventura di trovarsi nel suo cammino.
Le testimonianze che abbiamo raccolto dal nostro concittadino ingegnere Gulli, riportate nel saggio “Adrano dimora di dei”, e quelle consegnateci dal sig. Pellegriti circa il suo giovanile rinvenimento, ed esposte ne “I racconti del vespro”, raccontano del rinvenimento di scheletri che superavano i due metri di altezza, unendo i dati di tali rinvenimenti ai dati delle ricerche sulle abitudini di vita e alla simbologia adottata dagli abitanti neolitici del territorio adranita, come sopra affermato, aggiungendovi ancora le conclusioni delle ricerche sulla lingua parlata dai Sicani di cui rimangono importanti testimonianze epigrafiche, vengono confortate le tesi secondo le quale i Sicani fossero imparentati con i popoli del nord Europa.
Ad majora.
La roccia forata di Nissoria e i due corvi di Odino.

“Huginn e Muninn
Volavano ogni giorno
Alti intorno alla
Terra.
Io ho timore per Huginn
Che non ritorni;
Ma ho ancora più timore
Per Muninn”.
Dal poema eddico Grimnismal; canto XX.
Due eravamo noi, esploratori dell’arcano e due erano i corvi ad attenderci, appollaiati sulla cresta della rupe nella quale, rotondo, si apriva un grande foro ricavato in illo tempore, da mani umane, nella morbida arenaria da cui emergevano, qua e là, effetto delle carezze del tempo che involontariamente erodevano l’enorme plurimillenario sedimento, granchi e conchiglie depositatisi in epoca diluviana. Il tempo dirà, forse, chi di noi due impersonava Huginn e chi Muninn, i due corvi che accompagnavano sempre il dio monocolo, posati sulla spalla destra l’uno, sulla sinistra l’altro, rispettivamente: pensiero e memoria.

Questa breve prefazione vorrebbe introdurci agli studi che ci hanno indotto a formulare l’ipotesi che tra i Sicani, primi abitatori della Sicilia, isola che da loro, secondo le fonti dello storico greco Tucidide prese il nome di Sicania e la cultura scandinava vi fossero state delle correlazioni culturali. Non ritorneremo in questa sede sugli argomenti già trattati e pubblicati sul pregevole sito di miti3000.eu circa la possibilità della trasmissione di una conoscenza metafisica affidata ad un alfabeto che con quello runico avrebbe avuto delle affinità e gestito da una particolare casta sacerdotale, così come eviteremo di ripeterci riproponendo l’analisi di un simbolismo ricorrente sulla ceramica adranita del IV e III millennio a. C. e su pietra basaltica del VI sec. a.C., simbolismo che contribuisce, con la sua presenza, a consolidare la tesi di cui sopra. Rimandiamo, pertanto, agli articoli menzionati coloro che fossero appassionati di queste tematiche. Qui vorremmo soltanto indurre chi ci segue nei nostri studi, a riflettere sui luoghi, molti in Sicilia, che ospitano le su citate rocce forate, per tentare di intuire, essendo assenti le fonti antiche che ne spieghino la presenza, la loro funzione in seno alla visione del mondo che rendeva i nostri Avi attivi protagonisti di opere imponenti e detentori di conoscenze tramandate per vie criptiche. Opere queste, destinate anche ai posteri, avendo il mondo del loro tempo esaurito le energie di riproduzione deputate a generare neofiti degni di raccogliere le conoscenze trasmesse oralmente.
Prima, però, diamo luogo ad una breve riflessione sul significato etimologico dei nomi attribuiti ai due corvi di Odino. Metaforicamente essi alluderebbero alla sfera del mentale e dello spirituale, componenti che albergano nell’essere umano e che attivati secondo le circostanze permettono a quest’ultimo di interagire con la sfera ora del sacro, ora del profano, del mondo e del sovramondo. Il nesso consonantico MN che forma il nome Muninn (ma anche quello di Mnemosine, la dea nata dalla mente di Zeus e quello di Ramnes, secondo nome di Romolo, come afferma T. Livio. Non meno stupore procura l’affinità che esiste tra il nome del corvo con il sanscrito Muni, l’asceta tirato in causa nel testo più antico dei veda), significa mente; il radicale HG invece, che forma il nome del secondo corvo, Huginn, si riferisce alla sfera del sacro; infatti con il termine hug (Aug in latino, prefisso sacro dell’attributo Augusto e Augure.

Circa le concordanze linguistiche e culturali intercorrenti tra il mondo germanico e quello sicano, vedasi il nostro saggio: “Dalla S(i)cania alla Sicania”, gratuitamente fruibile nel sito di mitologia miti3000.eu) viene indicato, in lingua germanica, un luogo carico di energie extrafisiche positive. Il suono onomatopeico del lessema nordico hörgr, evoca invece, un luogo in cui si manifestano energie extrafisiche violente.

Ed infatti, con il su citato lessema, si indica un altare sacrificale sul quale, come viene affermato nel canto di Hyndla che riportiamo sotto, viene praticato un rito cruento, un rito durante il quale viene fatto scorrere il sangue della vittima: “Egli ha eretto in mio onore un hörgr di pietre ammonticchiate. Egli l’ha di fresco arrossato di sangue di giovenca”. Non intendiamo farci sfuggire l’occasione per far notare in questo breve articolo, ai nostri lettori, le analogie architettoniche che intercorrono tra la costruzione dell’hörgr germanico, l’altare di pietre a secco poste l’una sull’altra a formare un cumulo e una formazione esistente in una suggestiva contrada di Adrano, presso un luogo da cui trasuda la presenza di energie positive a motivo della Flora e della fauna presente, di cascatelle di acqua che scompaiono fra i canneti, ma di cui si ode l’armonico scroscio, di pareti laviche da cui, quali vene aperte, appaiono i rivoli che alimentano fresche sorgenti che estinguono l’arsura del colono affaticato e del paesaggio che si apre sulla valle del Simeto, cumulo che fin dal primo momento indicammo come una possibile ara di epoca neolitica.

Se da un lato tutte le civiltà conosciute praticavano riti cruenti, dall’altro venivano eseguiti pure riti augurali. Questi ultimi, nei luoghi a vocazione agricola, si svolgevano presso le rocce forate di cui ci stiamo occupando, antichi santuari della preistoria e che, smarrito il ricordo della loro funzione, il volgo chiama semplicemente “pietre perciate”. Generalmente esse si trovano fuori dai centri abitati di epoca preistorica, come si deduce dai rinvenimenti archeologici. Motivo per cui il rito che vi si praticava e che mette, a nostro avviso, in relazione ancora una volta la S(i)cania con la Sicania, oltre al rito del solstizio d’inverno, molto importante e tutt’oggi praticato da alcune frange della popolazione del nord Europa, riguardava la fecondazione simbolica del fertile suolo ad opera del raggio vitalizzante del sole. Infatti, i pacifici abitanti della Svezia, al contrario dei turbolenti Norvegesi che prediligevano riservare il loro culto al guerriero Thor, rivolgevano le loro attenzioni, prima che avvenisse la loro conversione al cristianesimo, appena nel 1008, conversione voluta per motivi politici da re Olaf, alla dea della fecondazione/fertilità Freyr. Il sole siciliano, nel giorno dell’equinozio di primavera, attraversava allora come oggi, con i suoi caldi raggi, il foro praticato nella roccia, per colpire il suolo, fecondarlo e farvi crescere copiose le messi. Il rito in questione, dunque, rappresentava una sorta di matrimonio sacro che univa i due piani, piani impersonati da Muninn e Huginn, metafora dualista degli aspetti metafisici del dio scandinavo: il mondo e il sovramondo; l’umano e il divino; il sacro e il profano. Un dualismo inteso non come antitesi o contrapposizione, ma come complementarietà necessaria per trascendere l’umano e giungere, attraverso l’atto creativo, alla formazione della trinità intesa come “sacra” unità. Soltanto ed esclusivamente attraverso il conseguimento della triade divina viene perseguita l’immortalità. Il terzo elemento che si forma dall’unione o fusione dei due elementi complementari rappresenta infatti il garante dell’immortalita’ oltre che dell’ordine costituito. L’erede rappresenta l’elemento che garantisce la prosecuzione, la perdurabilità dei due piani dell’essere, del dualismo, dell’alternanza necessaria (oscurità-luce; nascita-morte; uomo-donna). Ma il terzo elemento (giorno, vita, figlio) non può pervenire all’esistenza senza l’attuazione del rito, il rito dell’unione, della fecondazione. In Mesopotamia l’equilibrio cosmico veniva garantito attraverso la sacra unione simbolica del re con la sacerdotessa, – originariamente l’unione avveniva nella camera da letto allestita appositamente nella ziggurat, tra Dio e la sacerdotessa-. Fa poi riflettere la constatazione che gli Avi nostri volessero ridurre tutto ciò che ruota attorno all’uomo, in triade. La triade sembra essere il numero attorno al quale viene strutturata la genetica umana: i geni del DNA si poggiano su tre basi; le melanine sono di tre gruppi; le anomalie cromosomiche che portano ad alcune note malformazioni come quella dovuta alla sindrome di Down, sono dovute alle trisomie. Anche le aree del cervello, deputate a funzioni diverse, secondo la classificazione di Maclean sarebbero tre. Sul terreno dello spirito sono i Veda ad individuare una triplice designazione: “Om” “Tat”, “Sat”.
Ad majora.
Simeto: Aorta della Sicilia
SIMETO: AORTA DELLA SICILIA
La fluidità del fiume le cui acque scorrendo non sono mai le medesime, sembra essere in antitesi con l’eterna stabilità del primordiale colonnato lavico. Tuttavia, il primo e il secondo rappresentano, sotto antitetiche sembianze, le indomabile forze della natura. Ma ben altre forze albergano in questo luogo che tu, artista degli dei primordiali, hai sapientemente cristallizzato con i tuoi ispirati scatti. Risalendo le correnti, chi se ne rendesse degno, potrebbe vedere, non con occhi umani, giocose Ninfe che rincorrendosi tra i flutti e gli equiseti, schizzano miriadi di smeraldine gocce fluviali. Non si faccia scoprire l’umano osservatore che osi penetrare nel mondo delle divinità , poiché “Tremendi son gli Dei quando appaiono alla luce del sole”, e allora dietro un tronco secolare o una arenaria primordiale, in agguato, si scorgera’ Lui, il dio cornuto, il predatore di vergini, Pan, intento ad osservare le dee per rapire la più bella che, al suono del suo flauto, in estasi, senza indugio lo seguirà per concedersi a Lui affinché altri dei, frutto della incontenibile forza procreativa del dio della natura, popolino quei boschi decantati dal poeta mantovano.
Ascolterà, se ne è degno, non con umane orecchie, l’uomo che avrà l’ardire di continuare il viaggio risalendo i flutti e vincendo le ripide pareti laviche, nei pressi di un ponte che un tempo il genio romano eresse sfidando le cateratte del Simeto, i canti gregoriani di un sant’uomo la cui anima, abbandonato il suo minuto corpo, al paradiso rinunciando, preferì continuare eternamente a calcare quelle rive a lui care. Proprio in questo luogo, alzando lo sguardo, vedrai la diroccata chiesa che lo spirito del Santo non intende abbandonare; lì da presso, una fragorosa cascata precipita sul fiume, dando vita nel luogo ove l’una è l’altro si uniscono, ad una colonia di equiseti, segno della purezza delle acque di quel luogo, e di nuovo il senso del sacro ti sopraffarrà. Sì, perché in ogni epoca i medesimi luoghi produssero, nell’animo dell’uomo sensibile, le medesime emozioni, solo che ognuno le diede nomi diversi. Non solo, mio caro neofita, direi che ognuno lì, può incontrare il Genius loci utilizzando i magici strumenti dell’epoca sua; se al monaco furono congeniali i canti gregoriano o il messale e all’antico siculo l’alloro piuttosto che il sangue di un toro, per te la divinità fluviale si è specchiata nell’obiettivo della tua fotocamera.
Ad majora
Il vallo di Ducezio
Il titolo di questo articolo, con riferimento ad un ipotetico vallo edificato da Ducezio per arrestare l’avanzata dei Greci nell’entroterra siculo dell’isola di Sicilia, analogamente a quello ben più noto di Adriano, voluto dall’imperatore romano per arrestare il passaggio del popolo degli Scoti nell’impero, prende spunto dal ritrovamento delle poderose fondamenta di un muro edificato in illo tempore, presso il paesino etneo di Maletto in territorio di Bronte. Naturalmente non è, e non può essere provato neanche dalla nostra ricostruzione dei fatti storici del periodo, che la edificazione del muro sia stata realmente voluta dal duce siculo Ducezio, tuttavia la presenza del muro in questione ci fornisce la ghiotta occasione per tentare la ricostruzione di un periodo storico, quello del V sec. a.C. momento in cui la penetrazione greca nell’entroterra etneo raggiunse la massima virulenza. Nella targa esposta presso il muro, per volontà della Sovrintendenza ai Beni Culturali, si lascia sospesa ogni possibile interpretazione del motivo per il quale quel muro fosse stato eretto e il periodo storico (o preistorico) in cui venne eretto. Ma a noi, ricercatori indipendenti, è concesso, liberi da schemi accademici, se ben suffragate da prove letterarie, azzardare tesi sottoponendole direttamente al vaglio dei fedeli lettori, graditi destinatari a cui, fiduciosi, ne affidiamo l’analisi.
Se noi abbiamo richiamato il nome del duce siculo per dare risalto a questa incompresa opera di fortificazione, è perché egli, a nostro modo di vedere, nel suo doppio ruolo di sacerdote e capo militare (vedi l’articolo: “Gli Dei Palici e le sacre sponde del Simeto”), oppositore della politica espansionistica greca, viene direttamente chiamato in causa quale valente costruttore di fortezze, dallo storico Diodoro siculo. Il motivo che spinse il nostro principe all’intervento militare per arrestare l’avanzata greca nel cuore del centro religioso dell’isola, va ricercato nella constatazione che i Greci spingendosi oltre la semplice conquista territoriale, miravano a cancellare la storia, le ataviche tradizioni e la religione sicule, ma su ciò, per quanti volessero approfondire quei riferimenti di metastoria cui spesso facciamo riferimento, rimandiamo al succitato articolo. L’edificazione di muri di sbarramento quale tecnica di difesa bellica, raggiunse in Sicilia una efficacia ancora maggiore di quella affidata all’uso delle armi stesse, e il nostro duce, come afferma lo storico di Agira nella sua Biblioteca Storica, dimostrò di essere un grande stratega fortificando, durante il ventennio che lo vide protagonista e in ascesa nella riconquista dei territori erosi dai Greci ai Siculi, numerosi villaggi siculi spingendolo a fondare più di una città. La necessità di erigere un muro mastodontico, funzionale a sbarrare la via al nemico, produceva, tra l’altro, una devastante ricaduta psicologica sull’umore degli eserciti nemici. Si pensi, quale parametro di comparazione e di misura della fatica occorrente a superare la costruzione di un muro, seppur eretto in fretta e furia, a quello costruito dagli Achei a protezione del loro accampamento, e all’immane fatica che costò ai Troiani il tentativo di superarlo, senza tra l’altro riuscirvi. Il racconto Omerico fatto nell’Iliade è prezioso in quanto descrive i particolari e i metodi di costruzione del muro acheo. La fretta con la quale venivano costruite le fortificazioni murarie durante la fase dei combattimenti, rappresenta un prezioso parametro di confronto per comprendere la funzione e l’approssimazione delle opere militari di questo genere. Tucidide, per esempio, soffermandosi sulla celerità con cui venne costruito il muro di Atene, ne riconosce la carenza delle più elementari tecniche costruttive che ne compromettevano, oltre che l’estetica, la migliore stabilità.
Se del muro di Maletto rimangono solo labili tracce, il motivo va ricercato, a nostro giudizio, nello scopo per il quale esso fu eretto. Infatti esso andrebbe comparato alle barricate innalzate nel XIX secolo per le vie di Milano contro gli Austriaci invasori, alle trincee scavate sul Piave durante la prima guerra mondiale per arrestare l’avanzata austriaca e al muro acheo descritto da Omero di cui si è detto. Pertanto del muro di Maletto, come per le barricate anti austriache e i numerosi muri su cui Tucidide ampiamente si sofferma nella descrizione della guerra del Peloponneso che si propagò fino in Sicilia, innalzati da tutte le parti in causa: Siracusani, Cartaginesi, Siculi, cessata l’emergenza non se ne curò più nessuno, essi vennero, come detto, o abbattuti dagli stessi abitanti di quei luoghi subito dopo finita l’emergenza per ripristinare le vie d’accesso o li si affidarono all’incuria del tempo.
DATAZIONE E MOTIVAZIONE DELL’EREZIONE DEL MURO
 Proveremo ora, dopo aver formulato una ipotesi sul motivo per cui venne innalzato il muro di Maletto, a comprendere il contesto storico e il periodo cronologico durante il quale il vallo possa essere stato realizzato. Dall’esamina parziale del muro abbiamo potuto dedurre che si possa trattare di mura erette come vallo o ostacolo per fermare o rallentare l’avanzata dei Greci verso il territorio siculo, che si estendeva da quel punto fino alla costa tirrenica della Sicilia. Non passi inosservato il fatto che il muro oggi intersechi la strada statale 120 che, partendo da Adrano e costeggiando il fiume Simeto, attraversando la catena montuosa dei Nebrodi conduce alla costa tirrenica. Infatti riteniamo che la detta arteria sia la stessa che nel periodo storico da noi esaminato, mettesse in comunicazione i Siculi abitatori delle pendici dell’Etna con quelli della costa tirrenica. La stradale 120 rappresenta ancor oggi una importante via di comunicazione, una scorciatoia per gli abitanti dei paesi etnei che si trovano a sud e a occidente del vulcano che intendono raggiungere il litorale tirrenico. Questo percorso è infatti certamente preferibile a quello molto più lungo, anche se più agevole, di quello rappresentato dalla via costiera ionica. È verosimile che il muro sia stato posto in essere tra il 475 a. C., quando l’inviso ”tiranno” siracusano Jerone, fratello del ben amato “re” Gelone, ereditato il regno di Siracusa, pensò bene di accrescere il suo territorio a discapito di quello di Siculi, e il 414 a. C., quando la guerra del Peloponneso, combattuta in Grecia fra Greci, si espanse fino a raggiungere i confini della nostra isola. Nel primo caso (il 475 a.C.) è possibile che Jerone, dopo aver conquistato Catania e aver ottenuto dal senato cittadino di Innessa\Etna (futura Adrano, vedasi argomento dell’incontro tenuto nel Circolo Democratico di Adrano il 5-3-2017) il consenso di insediare simbolicamente una guarnigione siracusana nella città sicula, abbia indotto i Siculi che abitavano il territorio a monte di Innessa\Etna a spostare il vallo tutt’oggi visibile nella contrada del Mendolito, reso inefficace dalla guarnigione siracusana di stanza nella futura Adrano, più a monte, nel territorio dell’odierna Maletto. L’altra data, quella del 414 a. C. è perfettamente compatibile con il racconto che fa Tucidide nella Guerra del Peloponneso circa l’arte e la funzione della costruzione delle mura in corso di una guerra, come mezzo di ostacolo decisivo al risultato bellico. Afferma, infatti Tucidide: “Gli Ateniesi ripartirono per Nasso e, fatti fossati e palizzate attorno al campo vi svernarono (…) anche i Siracusani costruirono un muro attorno alla città (
Proveremo ora, dopo aver formulato una ipotesi sul motivo per cui venne innalzato il muro di Maletto, a comprendere il contesto storico e il periodo cronologico durante il quale il vallo possa essere stato realizzato. Dall’esamina parziale del muro abbiamo potuto dedurre che si possa trattare di mura erette come vallo o ostacolo per fermare o rallentare l’avanzata dei Greci verso il territorio siculo, che si estendeva da quel punto fino alla costa tirrenica della Sicilia. Non passi inosservato il fatto che il muro oggi intersechi la strada statale 120 che, partendo da Adrano e costeggiando il fiume Simeto, attraversando la catena montuosa dei Nebrodi conduce alla costa tirrenica. Infatti riteniamo che la detta arteria sia la stessa che nel periodo storico da noi esaminato, mettesse in comunicazione i Siculi abitatori delle pendici dell’Etna con quelli della costa tirrenica. La stradale 120 rappresenta ancor oggi una importante via di comunicazione, una scorciatoia per gli abitanti dei paesi etnei che si trovano a sud e a occidente del vulcano che intendono raggiungere il litorale tirrenico. Questo percorso è infatti certamente preferibile a quello molto più lungo, anche se più agevole, di quello rappresentato dalla via costiera ionica. È verosimile che il muro sia stato posto in essere tra il 475 a. C., quando l’inviso ”tiranno” siracusano Jerone, fratello del ben amato “re” Gelone, ereditato il regno di Siracusa, pensò bene di accrescere il suo territorio a discapito di quello di Siculi, e il 414 a. C., quando la guerra del Peloponneso, combattuta in Grecia fra Greci, si espanse fino a raggiungere i confini della nostra isola. Nel primo caso (il 475 a.C.) è possibile che Jerone, dopo aver conquistato Catania e aver ottenuto dal senato cittadino di Innessa\Etna (futura Adrano, vedasi argomento dell’incontro tenuto nel Circolo Democratico di Adrano il 5-3-2017) il consenso di insediare simbolicamente una guarnigione siracusana nella città sicula, abbia indotto i Siculi che abitavano il territorio a monte di Innessa\Etna a spostare il vallo tutt’oggi visibile nella contrada del Mendolito, reso inefficace dalla guarnigione siracusana di stanza nella futura Adrano, più a monte, nel territorio dell’odierna Maletto. L’altra data, quella del 414 a. C. è perfettamente compatibile con il racconto che fa Tucidide nella Guerra del Peloponneso circa l’arte e la funzione della costruzione delle mura in corso di una guerra, come mezzo di ostacolo decisivo al risultato bellico. Afferma, infatti Tucidide: “Gli Ateniesi ripartirono per Nasso e, fatti fossati e palizzate attorno al campo vi svernarono (…) anche i Siracusani costruirono un muro attorno alla città ( …) lo tracciarono lungo tutta quella parte che guarda le Epipole, perché, in caso di sconfitta, non li si potesse facilmente assediare a poca distanza dalla città” -libro VI,75-. Il contenuto di questo passo potrebbe adattarsi anche al nostro muro, costruito nei pressi di Maletto a sbarrare l’accesso al territorio siculo che veniva, tuttavia, continuamente eroso dai Greci. Lo sbarramento creato dai Siculi proprio in questo punto strategico risulta funzionale per una imboscata da tendere al nemico. Infatti, con la costruzione dell’imponente muro l’esercito nemico sarebbe rimasto facilmente imbottigliato in uno spazio di terreno e, se vogliamo attuare una storica comparazione, si sarebbe trovato nelle medesime condizioni dell’esercito Romano nel Sannio presso Caudio ove subì la storica umiliazione del giogo. Osservando l’orografia del luogo dell’edificazione del vallo si può osservare facilmente come l’esercito nemico che avesse avanzato verso l’interno dell’isola, dovendosi arrestare a causa del muro nello ampio spazio lasciato artatamente libero, avrebbe avuto impedita la fuga presso le retrovie poiché l’angusto passo alle loro spalle poteva venire facilmente sbarrato da un esiguo numero di militi siculi. Nel formulare questa ipotesi Tucidide sembra venirci ancora in soccorso. Così lo storico greco in VI,32\33: “Nicia manda messi a quei Siculi che controllavano i passaggi ed erano suoi alleati, i Centoripini, gli Alicei e altri, perché non lasciassero passare i nemici e impedissero di aprirsi il cammino (…) i Sicelioti tesero un agguato in tre punti (…) I Siracusani, dopo la disfatta subita nel paese dei Siculi, si trattennero dall’assalire subito gli Ateniesi”. Risulta assai agevole individuare perfino i tre punti non meglio precisati da Tucidide. Il primo potrebbe riferirsi a quello che si trovava tra Centuripe e Innessa (Adrano) fra le quali vi è la via che conduce nel paesino di Troina e poi da lì ancora più all’interno fino alla costa tirrenica; il secondo punto potrebbe corrispondere al passo di Maletto che stiamo esaminando, mentre il terzo potrebbe riferirsi a quello allora controllato dagli alleati Catanesi da cui si aveva accesso alla costa ionica. Per paese dei Siculi, come lo definisce Tucidide, di conseguenza, dovrebbe intendersi quella fascia dell’entroterra chiusa all’interno di questi tre passi e saldamente mantenuta dalle armi sicule. Attraverso la seguente ricostruzione storica da noi azzardata, emerge l’ipotesi che Il vallo di Maletto potrebbe essere stato eretto dopo la caduta di quello precedentemente posto nel territorio di Innessa\Adrano nell’attuale contrada Mendolito. Il poderoso vallo di Innessa di cui rimane ancora visibile un lungo tratto, potrebbe essere stato rinforzato dal duce siculo con le due torri erette a protezione della porta principale, così si giustifica altresì la presenza della famosa stele in lingua sicula presso questa porta. Il vallo di Innessa\Adrano, dopo la disfatta dei siculi guidati da Ducezio, avvenuta nel 444 a.C. potrebbe, dunque, essere stato spostato più a monte, nel villaggio di Maletto, oggi territorio di Bronte. Ritornando sull’affermazione di Tucidide circa il paese dei Siculi, riteniamo che egli intendesse riferirsi alla parte orientale della Sicilia appena descritta, poiché lo si evince dal contenuto del libro VI,62 in cui lo storico afferma che l’esercito ateniese dopo aver messo piede nella costa tirrenica, nei pressi di Himera: “unica città greca della costa (…) con la fanteria retrocedevano attraverso i territori dei Siculi finchè giunsero a Catania”. Dunque l’esercito sbarcato ad Himera potè procedere tranquillamente fino a Catania in quanto tutti i paesetti all’interno di questo territorio (il triangolo Himera-Messina-Catania) erano siculi ed erano loro alleati. Inoltre, riteniamo che questo territorio, a motivo della sua complessità orografica rappresentata principalmente dalla catena montuosa dei Nebrodi, non fosse stato mai sottoposto ad una vera pressione militare Greca, -ciò emerge anche in VI,86 ove si afferma: “ i villaggi dei Siculi che abitavano l’interno e che erano stati sempre autonomi fin da prima, subito, tranne alcuni, furono con gli Ateniesi”- al punto che Ducezio, dopo la definitiva disfatta militare del 444 a. C. che lo vide svernare a Corinto[1] per alcuni anni in un esilio dorato imposto dai Siracusani, nel suo ritorno in Sicilia, sbarcando sulla costa tirrenica, vi può tranquillamente fondare una città: kalè Aktè, l’attuale Caronia, vivere indisturbato e morirvi solo per il sopraggiungere di una malattia.
…) lo tracciarono lungo tutta quella parte che guarda le Epipole, perché, in caso di sconfitta, non li si potesse facilmente assediare a poca distanza dalla città” -libro VI,75-. Il contenuto di questo passo potrebbe adattarsi anche al nostro muro, costruito nei pressi di Maletto a sbarrare l’accesso al territorio siculo che veniva, tuttavia, continuamente eroso dai Greci. Lo sbarramento creato dai Siculi proprio in questo punto strategico risulta funzionale per una imboscata da tendere al nemico. Infatti, con la costruzione dell’imponente muro l’esercito nemico sarebbe rimasto facilmente imbottigliato in uno spazio di terreno e, se vogliamo attuare una storica comparazione, si sarebbe trovato nelle medesime condizioni dell’esercito Romano nel Sannio presso Caudio ove subì la storica umiliazione del giogo. Osservando l’orografia del luogo dell’edificazione del vallo si può osservare facilmente come l’esercito nemico che avesse avanzato verso l’interno dell’isola, dovendosi arrestare a causa del muro nello ampio spazio lasciato artatamente libero, avrebbe avuto impedita la fuga presso le retrovie poiché l’angusto passo alle loro spalle poteva venire facilmente sbarrato da un esiguo numero di militi siculi. Nel formulare questa ipotesi Tucidide sembra venirci ancora in soccorso. Così lo storico greco in VI,32\33: “Nicia manda messi a quei Siculi che controllavano i passaggi ed erano suoi alleati, i Centoripini, gli Alicei e altri, perché non lasciassero passare i nemici e impedissero di aprirsi il cammino (…) i Sicelioti tesero un agguato in tre punti (…) I Siracusani, dopo la disfatta subita nel paese dei Siculi, si trattennero dall’assalire subito gli Ateniesi”. Risulta assai agevole individuare perfino i tre punti non meglio precisati da Tucidide. Il primo potrebbe riferirsi a quello che si trovava tra Centuripe e Innessa (Adrano) fra le quali vi è la via che conduce nel paesino di Troina e poi da lì ancora più all’interno fino alla costa tirrenica; il secondo punto potrebbe corrispondere al passo di Maletto che stiamo esaminando, mentre il terzo potrebbe riferirsi a quello allora controllato dagli alleati Catanesi da cui si aveva accesso alla costa ionica. Per paese dei Siculi, come lo definisce Tucidide, di conseguenza, dovrebbe intendersi quella fascia dell’entroterra chiusa all’interno di questi tre passi e saldamente mantenuta dalle armi sicule. Attraverso la seguente ricostruzione storica da noi azzardata, emerge l’ipotesi che Il vallo di Maletto potrebbe essere stato eretto dopo la caduta di quello precedentemente posto nel territorio di Innessa\Adrano nell’attuale contrada Mendolito. Il poderoso vallo di Innessa di cui rimane ancora visibile un lungo tratto, potrebbe essere stato rinforzato dal duce siculo con le due torri erette a protezione della porta principale, così si giustifica altresì la presenza della famosa stele in lingua sicula presso questa porta. Il vallo di Innessa\Adrano, dopo la disfatta dei siculi guidati da Ducezio, avvenuta nel 444 a.C. potrebbe, dunque, essere stato spostato più a monte, nel villaggio di Maletto, oggi territorio di Bronte. Ritornando sull’affermazione di Tucidide circa il paese dei Siculi, riteniamo che egli intendesse riferirsi alla parte orientale della Sicilia appena descritta, poiché lo si evince dal contenuto del libro VI,62 in cui lo storico afferma che l’esercito ateniese dopo aver messo piede nella costa tirrenica, nei pressi di Himera: “unica città greca della costa (…) con la fanteria retrocedevano attraverso i territori dei Siculi finchè giunsero a Catania”. Dunque l’esercito sbarcato ad Himera potè procedere tranquillamente fino a Catania in quanto tutti i paesetti all’interno di questo territorio (il triangolo Himera-Messina-Catania) erano siculi ed erano loro alleati. Inoltre, riteniamo che questo territorio, a motivo della sua complessità orografica rappresentata principalmente dalla catena montuosa dei Nebrodi, non fosse stato mai sottoposto ad una vera pressione militare Greca, -ciò emerge anche in VI,86 ove si afferma: “ i villaggi dei Siculi che abitavano l’interno e che erano stati sempre autonomi fin da prima, subito, tranne alcuni, furono con gli Ateniesi”- al punto che Ducezio, dopo la definitiva disfatta militare del 444 a. C. che lo vide svernare a Corinto[1] per alcuni anni in un esilio dorato imposto dai Siracusani, nel suo ritorno in Sicilia, sbarcando sulla costa tirrenica, vi può tranquillamente fondare una città: kalè Aktè, l’attuale Caronia, vivere indisturbato e morirvi solo per il sopraggiungere di una malattia.
C’è un ulteriore passo nel lib. VI, 98 che serve a farci comprendere il motivo della velocità della messa in opera e funzione per cui questi muri venivano eretti e recita così: “Gli Ateniesi si mossero per Sice, dove si accamparono e rapidamente costruirono un muro circolare (…) costruirono il muro circolare portando pietre e legname (…) partendo dal porto grande fino all’altro mare (…) i Siracusani elevarono un muro trasversale la dove gli Ateniesi avrebbero dovuto condurre il loro muro e, se fossero stati più veloci, chiuderli fuori”. Il muro di Maletto ha un circuito circolare che sembra strategicamente eretto per essere funzionale ad imbottigliare un esercito nemico al suo interno. Infatti, inizia da un monte a sud del paese e finisce nella rocca sotto la quale scorre il fiume Simeto. Che il muro possa essere stato eretto per funzioni militari lo si evince dalla qualità edilizia dello stesso. Infatti, oltre a seguire l’andamento orografico del terreno, sfruttando avvallamenti ed elevazioni naturali al fine di risparmiare tempo e manodopera, il muro non ha caratteristiche né estetiche né di solidità stabile, caratteristiche indispensabili per la costruzioni dei muri di cinta che proteggevano le città (vedi mura di Adrano, Siracusa, Argo, Micene, Arpinio ecc.). Tuttavia non si creda che tali muri non adempissero egregiamente al ruolo per il quale erano stati concepiti. Infatti in VII,3 Tucidide afferma che i Siracusani si erano schierati “davanti alle mura degli Ateniesi”, mura che erano state solidamente erette a protezione del proprio accampamento. Nel nostro caso va notato che in prossimità del vallo vi era solo il piccolo villaggio di Maletto abitato da qualche migliaio di cittadini, e poi una enorme, desertica distesa lavica che avrebbe dovuto ospitare le tende dei militari siculi che arrivavano in piccoli contingenti dai piccolissimi centri abitati dei dintorni. Si evince pertanto che, se il muro dovesse soltanto servire a difendere il piccolo villaggio, le sue dimensioni e il dispendio di energie occorse per costruirlo sarebbero state sproporzionate per lo scopo che si riproponeva se sostenute soltanto dalle poche centinaia di uomini abili al lavoro che abitavano il villaggio di Maletto. Sarebbe stato più conveniente, in caso di imminente pericolo, -come fece il Gallo Vercingetorige, incendiando le città che sarebbero facilmente cadute, nella sua tattica antiromana e i Russi in quella antinazista; questi ultimi preferirono incendiare l’importante città di Stalingrado piuttosto che farla cadere nelle mani dei tedeschi-, sacrificare al nemico il piccolo villaggio e ripiegare verso l’interno. Invece il muro, come detto, aveva lo scopo di fungere da linea di demarcazione e di difesa non del singolo villaggio di Maletto, ma dell’intero territorio siculo rimasto, affinchè in esso potessero raccogliersi e organizzarsi i piccoli contingenti di eserciti provenienti dai piccolissimi villaggi siculi che oggi, come allora, popolavano l’entroterra e le selvatiche selve dei Nebrodi.
LE FAVARE O ACQUE SACRE
Lungo la parte meridionale esterna del muro di cui abbiamo detto sopra, è possibile assistere, durante i mesi primaverili, all’apparizione di un ruscello abbastanza ampio e suggestivo con la creazione di piccoli laghetti e cascate avendo come sfondo l’imponenza del vulcano Etna ancora imbiancato da quelle nevi che sciogliendosi hanno dato vita alle su dette “acque sacre”. Queste acque che ora si dividono in rivoli, ora si riuniscono in laghetti, vennero denominate sacre, come si evince dall’utilizzo del prefisso sacro Ve che va a comporre il nome Favare. Ve, in lingua germanica viene pronunciato fe. L’altro lessema che forma il nome composto è vara il quale, in quasi tutte le lingue indoeuropee, dal sanscrito al protogermanico, significa acqua. Proprio la caratteristica di queste acque, quella di apparire durante la primavera e sparire durante l’estate, gli ha fatto guadagnare l’aggettivo di sacre in quanto, per analogia riconduce al concetto di nascita e morte, nonché a quello di ciclicità che, ritualmente, si ripete ogni anno ad ogni stagione. Il loro apparire e sparire li collega al mito di Innanna fra i Sumeri; Proserpina fra i Greci; i Dioscuri nella mitologia greco romana; gli dèi Palici fra i Siculo/Sicani. Si osservi che questa coppia di gemelli venerati presso il Simeto, cantati da Virgilio nell’Eneide, erano denominati Delli che significa i nascosti in lingua tedesca. Il loro culto si svolgeva in un luogo dove scorrevano e continuano a scorrere dopo millenni, due fonti denominate di acqua chiara e di acqua scura, esse vengono dette acque delle Favare cioè acque sacre proprio come quelle di Maletto (ma ve ne sono molte altre in diversi luoghi della Sicilia) perchè esse stesse sono una trasposizione delle divinità. Nel caso delle favare di Maletto, il ruscello, come le dee sopra citate le quali trascorrevano sei mesi dell’anno negli inferi e sei nell’Olimpo, cioè metà anno nella oscurità e metà anno nella luce, rappresentano la metafora dell’eterno avvicendamento di morte e rinascita della natura. Infatti, come affermato sopra esso si forma in primavera grazie al primo scioglimento delle nevi dell’Etna e sparisce in estate quando le nevi, in virtù della cocente calura del sole siciliano si scioglieranno del tutto.
LA TOPONOMASTICA
 Anche la toponomastica del territorio di Bronte e Maletto come quella esistente nel territorio di Adrano di cui ci siamo occupati in articoli precedenti, riconduce ad una derivazione nord europea, lingua che abbiamo ritenuto parlassero i nostri avi Sicani e Siculi e di cui ci siamo serviti per una ipotesi di interpretazione delle epigrafi comunemente definite sicule, le più importanti ritrovate tra i territori Adrano e Centuripe (vedi l’articolo: (“Jam akaram: la lingua dei Sicani” ). Nebrodi è il nome dato alla catena montuosa la cui flora è caratterizzata dalla presenza di grandi distese di boschi di Pini e Querce, del tutto simili ai boschi che caratterizzano l’area geografica del nord Europa. Si può notare l’affinità del nome dei monti siciliani con quello di Nebra, cittadina della Germania in cui fu rinvenuto il famoso disco di bronzo che porta il suo nome. Il disco di Nebra, è stato datato dagli esperti e fatto risalire all’età del bronzo. Su di esso sembra sia stata riprodotta la costellazione delle Pleiadi oltre che il sole e la luna.
Anche la toponomastica del territorio di Bronte e Maletto come quella esistente nel territorio di Adrano di cui ci siamo occupati in articoli precedenti, riconduce ad una derivazione nord europea, lingua che abbiamo ritenuto parlassero i nostri avi Sicani e Siculi e di cui ci siamo serviti per una ipotesi di interpretazione delle epigrafi comunemente definite sicule, le più importanti ritrovate tra i territori Adrano e Centuripe (vedi l’articolo: (“Jam akaram: la lingua dei Sicani” ). Nebrodi è il nome dato alla catena montuosa la cui flora è caratterizzata dalla presenza di grandi distese di boschi di Pini e Querce, del tutto simili ai boschi che caratterizzano l’area geografica del nord Europa. Si può notare l’affinità del nome dei monti siciliani con quello di Nebra, cittadina della Germania in cui fu rinvenuto il famoso disco di bronzo che porta il suo nome. Il disco di Nebra, è stato datato dagli esperti e fatto risalire all’età del bronzo. Su di esso sembra sia stata riprodotta la costellazione delle Pleiadi oltre che il sole e la luna.
Piana Cuntarati, è il nome di una contrada che si trova tra Bronte e Maletto. Il nome della contrada entra curiosamente in relazione con un nome di persona ancora attuale e molto frequente presso i Tedeschi e gli Svedesi, quello di Gunter. Il toponimo Cuntarati sembra essere formato dall’accostamento dei lessemi Kuh vacca e tarn celato, nascosto. La libera traduzione che farebbe intendere che ci si trovi in un luogo di raduno di “vaccari”, appare verosimile se si tiene conto che quella del mandriano è una attività ancora importante e praticata nel territorio preso in esame. Nel dialetto brontese cuntari significa raccontare, contare, enumerare ma anche misurare. Dunque potrebbe essere stato, il nostro, un luogo ove le mandrie provenienti da luoghi vicini, venivano riunite, “contate”, controllate. Non va trascurato il linguaggio metaforico di cui amavano servirsi i nostri avi (di conseguenza il bue potrebbe racchiudere il significato di guerriero, militare. In questa accezione lo utilizza, per esempio Zarathustra nel suo elogio al principe quando gli augura di avere molte vacche nelle sue stalle), continuato attraverso i poeti e le loro poesie. Pertanto pur volendo considerare la possibilità che il significato del toponimo rientri nella accezione di enumerare, il riferimento potrebbe comunque andare alla mandria e al concetto di moltitudine, di gruppo. Infatti in semitico il numero 1.000 viene espresso con la parola bue. Nella antica scrittura ideografica utilizzata da diversi popoli si prendeva quale simbolo per esprimere il concetto di moltitudine la figura del salmone. Infatti in India, luogo in cui non si sarebbe dovuto conoscere questo pesce che vive solo nelle acque dei fiumi che sfociano nel Mar del Nord e nel Mar Baltico, con la parola sanscrita Laksa, nome con il quale viene chiamato in Germania il salmone (Lachs), viene espresso il numero 100.000. Il salmone, spostandosi in branchi fornisce, infatti, l’idea della moltitudine da cui origina il numero centomila.
Maletto è un piccolo centro arroccato sulle falde dell’Etna. Come testimoniano i reperti archeologici ivi rinvenuti, esso è stato abitato fin dal VI millennio a. C. Secondo la tradizione il toponimo è stato acquisito dal nome del duca Maletta il quale, del villaggio ne fece la propria residenza edificandovi il castello di cui ne rimangono le rovine. L’edificio, a sua volta, venne costruito sulle rovine di una precedente struttura non meglio identificata. Non è difficile dedurre che, secondo le abitudini sicane per ciò che concerne la fondazione delle loro città, la rupe che domina la valle, e su cui insistono i ruderi del castello, corrispondeva all’acropoli che, certamente, ospitava il tempio del nume tutelare del villaggio. Il nome del duca, e dunque del villaggio, riconducono al lessema nordico Mehl, termine che significa farina. Non sembri cosa poco importante la constatazione che durante il pranzo, prima di mettere mano al cibo, i Tedeschi pronunciano la frase mahl zeit, l’equivalente del buon appetito pronunciato da noi Italiani. Il lessema Mehl lo si ritrova inciso in un blocco di pietra arenaria ritrovato in Svezia nella città di Tune datato intorno al 500 circa. Nelle tre righe dell’epigrafe runica un sacerdote si autodefinisce il custode della farina, Mehl. Poiché il cognome Mele è comunissimo nel territorio di Bronte e Maletto è possibile dedurre che il nome o forse l’epiteto, sia diventato il titolo nobiliare attribuito al duca di Maletto e che in Illo tempore fosse stato utilizzato per indicare in genere un “benefattore o elargitore del pane” o, se vogliamo seguire la tradizione ariana dell’Avesta, il libro sacro degli Irani, l’ordinatore, poiché in esso viene testualmente affermato: ”Colui che diligentemente semina il grano, o Spitama Zarathustra, colui che semina il grano, edifica l’ordine”. Se poi, la vicina cittadina di Randazzo corrispondesse, come ipotizzato dagli studiosi, alla Tissa citata da Cicerone nelle verrine, avremo che nella lingua germanica il termine significherebbe tavola, mensa (Tisch in tedesco)
 Tornando al toponimo Cuntarati con cui si è denominata la contrada su citata, alla luce di quanto detto sopra a proposito del rinvenimento della stele runica in Svezia, nazione in cui vi è una regione denominata Gotland dalla quale provengono i Goti, vi si potrebbe azzardare una ulteriore ipotesi interpretativa considerando che il toponimo Guntarati possa indicare un etnico. Infatti, il prefisso ku o Gut potrebbe riferirsi al popolo dei Goti. Essi vengono denominati dagli storici antichi, ora utilizzando l’etnico di Gutei ora quello di Kutei. Il lessema tarn che segue al nome di Gutei, significa celare, nascondere, pertanto il toponimo Ku-tarn potrebbe indicare un luogo ove una minoranza di Goti avrebbe potuto trovare ricovero, nascondersi o celarsi. In questo caso potremmo ipotizzare che il toponimo avesse trovato applicazione nel periodo che vide i Normanni (di origine scandinava) opporsi ai Saraceni che avevano occupato l’isola. Il nome della contrada potrebbe derivare, altresì, dal nordico kunun con il significato di re e tarn indicando un luogo dove sarebbe stato un re a trovarvi ricovero. Anche per ciò che concerne il termine Mehl farina, pane, riteniamo che le ipotesi sul suo significato potrebbero essere diverse. Esso potrebbe essere stato utilizzato in chiave metaforica per sottintendere un nutrimento spirituale. Infatti il termine va a comporre, tra gli altri, il nome del sacerdote Melkisedek colui che iniziò Abramo proprio utilizzando ritualmente il pane. Non passerà inosservato neppure l’utilizzo del pane quale mezzo rituale, di cui si serve il principe ittita Labarna. Ma per ciò rinviamo, chi ne avesse interesse, al nostro saggio, disponibile gratuitamente sul sito di miti3000.eu: “Il paganesimo di Gesù”.
Tornando al toponimo Cuntarati con cui si è denominata la contrada su citata, alla luce di quanto detto sopra a proposito del rinvenimento della stele runica in Svezia, nazione in cui vi è una regione denominata Gotland dalla quale provengono i Goti, vi si potrebbe azzardare una ulteriore ipotesi interpretativa considerando che il toponimo Guntarati possa indicare un etnico. Infatti, il prefisso ku o Gut potrebbe riferirsi al popolo dei Goti. Essi vengono denominati dagli storici antichi, ora utilizzando l’etnico di Gutei ora quello di Kutei. Il lessema tarn che segue al nome di Gutei, significa celare, nascondere, pertanto il toponimo Ku-tarn potrebbe indicare un luogo ove una minoranza di Goti avrebbe potuto trovare ricovero, nascondersi o celarsi. In questo caso potremmo ipotizzare che il toponimo avesse trovato applicazione nel periodo che vide i Normanni (di origine scandinava) opporsi ai Saraceni che avevano occupato l’isola. Il nome della contrada potrebbe derivare, altresì, dal nordico kunun con il significato di re e tarn indicando un luogo dove sarebbe stato un re a trovarvi ricovero. Anche per ciò che concerne il termine Mehl farina, pane, riteniamo che le ipotesi sul suo significato potrebbero essere diverse. Esso potrebbe essere stato utilizzato in chiave metaforica per sottintendere un nutrimento spirituale. Infatti il termine va a comporre, tra gli altri, il nome del sacerdote Melkisedek colui che iniziò Abramo proprio utilizzando ritualmente il pane. Non passerà inosservato neppure l’utilizzo del pane quale mezzo rituale, di cui si serve il principe ittita Labarna. Ma per ciò rinviamo, chi ne avesse interesse, al nostro saggio, disponibile gratuitamente sul sito di miti3000.eu: “Il paganesimo di Gesù”.
Ad majora.
[1] Ducezio, una ventina di anni prima che la guerra del Peloponneso si spingesse fino in Sicilia, si trovava in esilio in Grecia, a Corinto. Qui, essendo libero di muoversi, ebbe intensi rapporti con le famiglie più ragguardevoli di Atene. Abbiamo buoni motivi per affermare che in questa fase il duce siculo concordasse con gli Ateniesi una strategia militare comune che li vedesse futuri alleati in una campagna militare condotta contro i Siracusani. Questi accordi diedero buoni motivi agli Ateniesi per intervenire nei fatti siciliani nonostante la prematura morte del duce, poiché in Sicilia avrebbero potuto, comunque, ancora contare sull’alleanza del potente principe siculo Arconide (lib. VII,1) il quale aveva collaborato con Ducezio nel sostenere la causa sicula e che al suo ritorno dall’esilio lo aveva aiutato a fondare Kalè Aktè.



